(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
Se gli Stati Uniti, così come la Gran Bretagna, in passato hanno visto la nascita di personaggi capaci, con la propria opera, di influenzare intere generazioni di musicisti, anche l’Italia non è certo rimasta a guardare, tutt’altro. Soprattutto il panorama rock nostrano, nelle sue più svariate sfaccettature, ha visto l’alternarsi di entità in grado di attrarre alla propria fonte musicale innumerevoli discepoli, tracciando così la via per lo sviluppo delle più varie correnti sonore. A questo ristretto gruppo di capiscuola vanno ascritti di diritto, nonostante la loro seppur breve vita discografica, Il Santo Niente, creatura partorita dalla mente di Umberto Palazzo, tra i più venerati profeti del post-punk made in Italy. Una discografia la loro composta da tre album, dei quali Il Fiore dell’Agave rimane ad oggi l’apice creativo, e due EP, dal peso specifico indubbiamente notevole. Proprio all’estro di Palazzo, è rivolto questo omaggio, tributato dalla crème de la crème del rock alternativo nostrano. Tributo fortemente voluto da Marco Gargiulo, giovanissimo timoniere della Mag-Music che, con la collaborazione della Disco Dada Records, ha approntato un album strutturato con criterio e cognizione di causa. Simona Gretchen & La mela e Newton, Giorgio Canali & Rossofuoco, Zippo, Spiral69, Motel 20099, Devocka, sono solo alcune delle band chiamate a rendere il proprio omaggio alla musica de Il Santo Niente, cercando allo stesso tempo di infondere in essa i propri stilemi sonori, con un occhio e un orecchio alla versioni primigenie. Inizio in grande stile con la ripresa di Junkie ad opera di Simona Gretchen, accompagnata da La mela e Newton, la quale tinge di sfumature dark il brano originale, con le voci femminili a rendere il tutto ancora più suadente e sensuale. Ottimo come sempre Giorgio Canali che, con l’aiuto dei suoi fidi Rossofuoco, rilegge da par suo Luna Viola, smussandone in parte i primitivi spigoli sonori, per una versione dall’alto tasso emotivo. Gli Zippo, dal canto loro, ripercorrono filologicamente il pentagramma di Cuore di Puttana, costruendo una sorta di ponte musicale tra la vecchia e la nuova formazione de Il Santo Niente, della quale Tonino Bosco e Federico Sergente, rispettivamente basso e batteria degli stessi Zippo, fanno ora parte. Ogni singola interpretazione meriterebbe tuttavia di essere menzionata, sia per quanto riguarda l’originalità dell’esecuzione, sia per la capacità espressa dai singoli musicisti di rimandare al contempo alle atmosfere delle opere originali. Degne di nota sono senza dubbio l’energetiche reinterpretazioni di Generazioni e Maelstrom, ad opera rispettivamente di Veracrash e Devocka, così come il trattamento elettronico riservato dagli Spiral69 ad Elvira, trasposta per l’occasione in inglese. I Motel 20099 si divertono invece a riproporre, in chiave indie-rock e con ottimi risultati, Angelo Nero. Questo Generazioni rappresenta un’ideale summa artistica dell’opera de Il Santo Niente, riletta attraverso gli strumenti di una folta schiera di adepti, mossi da una fede viscerale nei propri maestri sonici. Un eccellente punto di partenza, pertanto, per i neofiti della musica di Umberto Palazzo, nonché un piacevole divertissement per coloro che già masticano da tempo la musica della band.
venerdì 30 dicembre 2011
lunedì 19 dicembre 2011
Gionata Mirai - Allusioni
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
Coraggioso, questo è il primo aggettivo che viene spontaneo associare ad Allusioni, piccola gemma sonora a nome Gionata Mirai. Il leader dei Super Elastic Bubble Plastic, nonché chitarrista del Teatro degli Orrori, ha infatti confezionato un album, che rappresenta un profondo e netto taglio con quanto fatto in passato. Abbandonando le sonorità dei suoi progetti principali, il nostro ha portato avanti una propria intima ricerca sonora, effettuata con la sola compagnia della propria fedele dodici corde.
Risultato di questa esplorazione musicale interiore è appunto Allusioni che, nella sua seppur breve durata, riesce a condensare al suo interno molteplici influenze, in un caleidoscopico viaggio acustico tra le sonorità e le emozioni più diverse. Prendendo infatti spunto da opere di visionari quanto geniali chitarristi come John Fahey, solo per citare il più rappresentativo, Mirai ci accompagna in un excursus musicale tra aerei arrangiamenti, sinuosi esercizi di fingerpicking e plumbee inflessioni acustiche. L’estro faheyiano è solo il punto di partenza per digressioni sonore verso melodie richiamanti opere di artisti come Bert Jansch o l’Incredible String Band, nonché le bucoliche atmosfere folk delle quali esse sono intrise. C’è spazio anche per sonorità più cupe e claustrofobiche, che tendono tuttavia ad aprirsi verso eterei arpeggi quasi barocchi. Ciò che colpisce è la bravura tecnica di Mirai sul proprio strumento, tanto da farlo diventare parte integrante del proprio sé, nonché sua unica e profonda voce musicale, attraverso la quale canalizzare un alquanto ispirato songwriting.
E’ un disco sicuramente non immediato Allusioni, oltre che atipico all’interno della scena musicale italiana, ma proprio per questo rappresenta una splendida quanto gradita sorpresa. Citando le parole dello stesso Mirai, poste in copertina; “Forse vale la pena esserci (e aggiunge il sottoscritto, ascoltare con attenzione) anche solo per vedere come va a finire”.
Coraggioso, questo è il primo aggettivo che viene spontaneo associare ad Allusioni, piccola gemma sonora a nome Gionata Mirai. Il leader dei Super Elastic Bubble Plastic, nonché chitarrista del Teatro degli Orrori, ha infatti confezionato un album, che rappresenta un profondo e netto taglio con quanto fatto in passato. Abbandonando le sonorità dei suoi progetti principali, il nostro ha portato avanti una propria intima ricerca sonora, effettuata con la sola compagnia della propria fedele dodici corde.
Risultato di questa esplorazione musicale interiore è appunto Allusioni che, nella sua seppur breve durata, riesce a condensare al suo interno molteplici influenze, in un caleidoscopico viaggio acustico tra le sonorità e le emozioni più diverse. Prendendo infatti spunto da opere di visionari quanto geniali chitarristi come John Fahey, solo per citare il più rappresentativo, Mirai ci accompagna in un excursus musicale tra aerei arrangiamenti, sinuosi esercizi di fingerpicking e plumbee inflessioni acustiche. L’estro faheyiano è solo il punto di partenza per digressioni sonore verso melodie richiamanti opere di artisti come Bert Jansch o l’Incredible String Band, nonché le bucoliche atmosfere folk delle quali esse sono intrise. C’è spazio anche per sonorità più cupe e claustrofobiche, che tendono tuttavia ad aprirsi verso eterei arpeggi quasi barocchi. Ciò che colpisce è la bravura tecnica di Mirai sul proprio strumento, tanto da farlo diventare parte integrante del proprio sé, nonché sua unica e profonda voce musicale, attraverso la quale canalizzare un alquanto ispirato songwriting.
E’ un disco sicuramente non immediato Allusioni, oltre che atipico all’interno della scena musicale italiana, ma proprio per questo rappresenta una splendida quanto gradita sorpresa. Citando le parole dello stesso Mirai, poste in copertina; “Forse vale la pena esserci (e aggiunge il sottoscritto, ascoltare con attenzione) anche solo per vedere come va a finire”.
giovedì 15 dicembre 2011
Laura Marling - A creature I don't know
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
Ci sono ben pochi esordienti in grado di suscitare un tale scalpore come avvenuto per il debutto di Laura Marling, Alas I Cannot Swim. La giovane musicista, allora solo 18enne, fu infatti capace di conquistare immediatamente critica e pubblico, complice un album dalla bellezza adamantina, emanante arie antiche, provenienti direttamente dalla tradizione musicale britannica. Un lavoro che mostrava una cantautrice già matura, dal talento compositivo cristallino, tanto da ispirare parallelismi con veri e propri giganti del folk albionico come Sandy Denny e Nick Drake. A molti l’altisonante paragone potrebbe risultare fuori luogo, ma è invece proprio dai solchi tracciati da questi ultimi che la Marling si muove, andandosi ad inserire di diritto tra i maggiori esponenti della scena folk revival britannica. Il secondo album in studio, I Speak Because I Can, dimostrava una volta di più che la Nostra non era un fuoco di paglia, bensì una splendida realtà. Un talento in crescita esponenziale, come peraltro confermato da A Creature I Don’t Know, sua ultima e affascinante creatura discografica. Un album dai toni tenui e soffusi, intriso di liricità folk, del quale elementi portanti sono la voce e la chitarra acustica della Marling. Ad accompagnare la cantautrice, troviamo dietro al banco di regia niente meno che Ethan Johns (produttore in passato per artisti del calibro di Ryan Adams e Ray LaMontagne), che cuce addosso alle canzoni suadenti e avvolgenti arrangiamenti. Esempio perfetto di questo lavoro congiunto è l’opener The Muse, folk arcaico dall’andamento swingante, dove la voce e la chitarra della Marling vengono attorniate da una sezione ritmica che suona in punta di piedi alla quale si aggiungono precisi interventi di piano e banjo. Elementi che ritroviamo anche nella successiva I Was Just A Card, che parte in sordina per poi aprirsi in tutta la sua bellezza, grazie anche ad un azzeccato uso degli archi. L’eterea ballata Don’t Ask Me Why è invece una sorta di viaggio attraverso paesaggi musicali tanto cari al folk vecchio stampo, con l’espressiva voce della Marling come guida. Salinas prende invece spunto dalla lettura di una biografia di John Steinbeck, per spostare l’asse musicale verso assolati lidi americani. Soffusa è la toccante Rest In My Bed” che si avvicina alle malinconiche atmosfere di matrice drakeniana. L’intensa My Friend e l’agreste Sophia si mantengono invece nel solco acustico che dalla tradizione musicale britannica arriva sino ai giorni nostri. Semplicemente da brividi è Night After Night, per sola voce e chitarra, capace di incantare dalla prima all’ultima nota. Le vere perle dell’album sono tuttavia The Beast e la conclusiva All My Rage. La prima parte quasi in sordina per poi espandersi in un trascinante crescendo elettrico, mostrandoci un’anima diversa dell’artista, la cui voce in questo frangente sembra rimandare ad una giovane Patti Smith; mentre la seconda tra banjo, violini e percussioni unisce elementi tradizionali con architetture sonore debitrici nei confronti del new folk di gruppi come Mumford and Sons.
Un piccolo capolavoro questo A Creature I Don’t Know, dalla struggente bucolicità e dalle seducenti melodie, che sono sicuro saprà affascinare più di un ascoltatore. Nella perfida Albione continuano a nascere straordinari talenti e Laura Marling è uno di questi.
Ci sono ben pochi esordienti in grado di suscitare un tale scalpore come avvenuto per il debutto di Laura Marling, Alas I Cannot Swim. La giovane musicista, allora solo 18enne, fu infatti capace di conquistare immediatamente critica e pubblico, complice un album dalla bellezza adamantina, emanante arie antiche, provenienti direttamente dalla tradizione musicale britannica. Un lavoro che mostrava una cantautrice già matura, dal talento compositivo cristallino, tanto da ispirare parallelismi con veri e propri giganti del folk albionico come Sandy Denny e Nick Drake. A molti l’altisonante paragone potrebbe risultare fuori luogo, ma è invece proprio dai solchi tracciati da questi ultimi che la Marling si muove, andandosi ad inserire di diritto tra i maggiori esponenti della scena folk revival britannica. Il secondo album in studio, I Speak Because I Can, dimostrava una volta di più che la Nostra non era un fuoco di paglia, bensì una splendida realtà. Un talento in crescita esponenziale, come peraltro confermato da A Creature I Don’t Know, sua ultima e affascinante creatura discografica. Un album dai toni tenui e soffusi, intriso di liricità folk, del quale elementi portanti sono la voce e la chitarra acustica della Marling. Ad accompagnare la cantautrice, troviamo dietro al banco di regia niente meno che Ethan Johns (produttore in passato per artisti del calibro di Ryan Adams e Ray LaMontagne), che cuce addosso alle canzoni suadenti e avvolgenti arrangiamenti. Esempio perfetto di questo lavoro congiunto è l’opener The Muse, folk arcaico dall’andamento swingante, dove la voce e la chitarra della Marling vengono attorniate da una sezione ritmica che suona in punta di piedi alla quale si aggiungono precisi interventi di piano e banjo. Elementi che ritroviamo anche nella successiva I Was Just A Card, che parte in sordina per poi aprirsi in tutta la sua bellezza, grazie anche ad un azzeccato uso degli archi. L’eterea ballata Don’t Ask Me Why è invece una sorta di viaggio attraverso paesaggi musicali tanto cari al folk vecchio stampo, con l’espressiva voce della Marling come guida. Salinas prende invece spunto dalla lettura di una biografia di John Steinbeck, per spostare l’asse musicale verso assolati lidi americani. Soffusa è la toccante Rest In My Bed” che si avvicina alle malinconiche atmosfere di matrice drakeniana. L’intensa My Friend e l’agreste Sophia si mantengono invece nel solco acustico che dalla tradizione musicale britannica arriva sino ai giorni nostri. Semplicemente da brividi è Night After Night, per sola voce e chitarra, capace di incantare dalla prima all’ultima nota. Le vere perle dell’album sono tuttavia The Beast e la conclusiva All My Rage. La prima parte quasi in sordina per poi espandersi in un trascinante crescendo elettrico, mostrandoci un’anima diversa dell’artista, la cui voce in questo frangente sembra rimandare ad una giovane Patti Smith; mentre la seconda tra banjo, violini e percussioni unisce elementi tradizionali con architetture sonore debitrici nei confronti del new folk di gruppi come Mumford and Sons.
Un piccolo capolavoro questo A Creature I Don’t Know, dalla struggente bucolicità e dalle seducenti melodie, che sono sicuro saprà affascinare più di un ascoltatore. Nella perfida Albione continuano a nascere straordinari talenti e Laura Marling è uno di questi.
mercoledì 14 dicembre 2011
The Black Keys - El Camino
 C'erano una volta, in uno sperduto paese di nome Akron, due giovani ragazzi; il primo, Dan, dalla sfrenata passione per la musica e per la chitarra in particolare, mentre il secondo, Patrick, un improbabile quanto bizzarro incrocio tra un nerd e Buddy Holly. Ciò che univa questi due ragazzi era un'insana venerazione nei confronti di un bluesman, Junior Kimbrough, tanto da spingerli a formare un duo, nel quale far confluire il ruvido blues di quest'ultimo, con l'urgenza espressiva tipica del garage rock. Registrato un primo demo, trovato in Black Keys un nome pressochè perfetto, e firmato per la mitica Fat Possum, i due cominciarono a portare la loro musica in lungo e in largo per gli Stati Uniti, su di uno scassato ma fedele furgone. Dopo i primi successi di critica e pubblico, il futuro sembrava essere roseo per i nostri, fino a quando non incontrarono sulla loro strada un oscuro personaggio, tal Danger Mouse, il quale ne soggiogò il talento, tramutandoli sì in due affermate rockstar, ma allo stesso tempo privandoli della loro primitiva e grezza anima bluesy. Non aspettatevi tuttavia un finale lieto, non siamo in una fiaba dei fratelli Grimm, qui non vi sono eroi senza macchia o arditi cavalieri capaci di sconfiggere il malvagio Danger Mouse, liberando così il duo dalla sua gabbia dorata. Il perfido produttore mantiene tuttora saldamente nelle proprie mani lo scettro del potere, come peraltro si può evincere dall'ascolto di El Camino, ultima uscita discografica marchiata Black Keys. Con questo nuovo lavoro i nostri eroi si perdono ulteriormente nelle intricate trame del labirinto sonoro ideato dallo stesso Danger Mouse, tra ammiccamenti quasi pop e suoni spesso tronfi e ruffiani. Se l'obiettivo di El Camino era quello di accrescere ulteriormente la fama del duo, bisogna dire che esso assolve degnamente al proprio compito. Tutto pare pensato, studiato, scritto e suonato per poi essere riproposto nelle grandi arene, a cominciare dall'opener e primo singolo Lonely boy. Quest'ultima ha il suo punto di forza in un pressochè irresistibile riff di chitarra nonchè in un refrain killer capace di mietere vittime fin dal primo ascolto. Un deciso cambiamento di sonorità si avverte già con la successiva Dead and gone, che vira verso lidi cari a Joe Strummer e ai suoi Clash, ai quali la chitarra pare ispirarsi, prima che l'intero brano venga rovinato da un irritante uso delle voci. Gold on the ceiling cerca di fondere le atmosfere hard blues degli esordi con squarci psichedelici e sonorità più moderne, in quello che alla fine risulta comunque essere un intrigante pastiche sonoro. Little black submarines pare arrivare dall'esordio solista di Auerbach, e prendendo spunto dalla zeppeliniana Stairway to heaven, ne ricalca l'impianto strumentale, iniziando quasi in sordina, acustica, per poi esplodere nel finale in un elettrico tourbillon sonoro. I vecchi Black Keys tornano nuovamente a fare capolino in Money maker, sporco ed incalzante garage rock, materia nella quale i nostri dimostrano ancora di saper eccellere, come peraltro ribadito dalla successiva Run right back, seppur penalizzata da ulteriori iniezioni moderniste. Hell of a season riprende in parte le sonorità di Lonely boy senza però possedere l'appeal di quest'ultima. Definire oscene Sister e Stop stop sarebbe far loro un complimento; la prima un hard funk senza capo nè coda, mentre la seconda è da ascrivere tra i brani più insulsi ascoltati quest'anno, complice anche un ritornello che sfocia verso certa faciloneria pop. Nova baby ha un che di strokesiano, rubacchiando a piene mani dal catalogo musicale di Casablancas e soci, risultando alla fin fine piacevole e poco più. La conclusiva Mind eraser nulla aggiunge e nulla toglie all'economia dell'album; un onesto e robusto rock dalle reminescenze blues, senza infamia nè lode. Quello che balza subito all'orecchio, dopo l'ascolto dell'intero disco, è tuttavia un generale appiattimento musicale, una banalizzazione della formula sonora che da sempre aveva caratterizzato l'opera del duo di Akron. Vittime sacrificali sono senza dubbio la voce e la chitarra di Auerbach, mai come in quest'occasione addomesticate, svuotate e tenute quasi a freno; così come l'operato dietro ai tamburi di Carney, il cui drumming tanto furioso quanto originale pare essere solo un lontano ricordo, sostituito da un insipido e scontato accompagnamento ritmico. Gran parte della colpa è, a mio avviso, da ascrivere all'operato, dietro al banco di regia, di Danger Mouse, il quale è riuscito ancora una volta a deturpare quello che potenzialmente poteva essere un disco più che discreto, seppur privo del carattere e della personalità dei primi lavori. Speriamo almeno che on stage i nostri riescano a far riemergere la loro primordiale e infuocata anima blues, da veri animali da palcoscenico quali sono. Sono comunque certo che El Camino saprà mietere consensi sia di critica che di pubblico, come peraltro testimoniato dal sold out dell'unica data italiana del duo. A chi scrive piace, malgrado ciò, ritornare con la mente agli inizi della favola del duo di Akron, quando i nostri erano ancora due giovani e imberbi ragazzi della profonda provincia americana, che giravano su di un vecchio furgone con la musica di Junior Kimbrough a tutto volume. E ora scusatemi, ma andrò ad ascoltarmi nuovamente quel piccolo gioiello che era e rimane Thickfreakness.
C'erano una volta, in uno sperduto paese di nome Akron, due giovani ragazzi; il primo, Dan, dalla sfrenata passione per la musica e per la chitarra in particolare, mentre il secondo, Patrick, un improbabile quanto bizzarro incrocio tra un nerd e Buddy Holly. Ciò che univa questi due ragazzi era un'insana venerazione nei confronti di un bluesman, Junior Kimbrough, tanto da spingerli a formare un duo, nel quale far confluire il ruvido blues di quest'ultimo, con l'urgenza espressiva tipica del garage rock. Registrato un primo demo, trovato in Black Keys un nome pressochè perfetto, e firmato per la mitica Fat Possum, i due cominciarono a portare la loro musica in lungo e in largo per gli Stati Uniti, su di uno scassato ma fedele furgone. Dopo i primi successi di critica e pubblico, il futuro sembrava essere roseo per i nostri, fino a quando non incontrarono sulla loro strada un oscuro personaggio, tal Danger Mouse, il quale ne soggiogò il talento, tramutandoli sì in due affermate rockstar, ma allo stesso tempo privandoli della loro primitiva e grezza anima bluesy. Non aspettatevi tuttavia un finale lieto, non siamo in una fiaba dei fratelli Grimm, qui non vi sono eroi senza macchia o arditi cavalieri capaci di sconfiggere il malvagio Danger Mouse, liberando così il duo dalla sua gabbia dorata. Il perfido produttore mantiene tuttora saldamente nelle proprie mani lo scettro del potere, come peraltro si può evincere dall'ascolto di El Camino, ultima uscita discografica marchiata Black Keys. Con questo nuovo lavoro i nostri eroi si perdono ulteriormente nelle intricate trame del labirinto sonoro ideato dallo stesso Danger Mouse, tra ammiccamenti quasi pop e suoni spesso tronfi e ruffiani. Se l'obiettivo di El Camino era quello di accrescere ulteriormente la fama del duo, bisogna dire che esso assolve degnamente al proprio compito. Tutto pare pensato, studiato, scritto e suonato per poi essere riproposto nelle grandi arene, a cominciare dall'opener e primo singolo Lonely boy. Quest'ultima ha il suo punto di forza in un pressochè irresistibile riff di chitarra nonchè in un refrain killer capace di mietere vittime fin dal primo ascolto. Un deciso cambiamento di sonorità si avverte già con la successiva Dead and gone, che vira verso lidi cari a Joe Strummer e ai suoi Clash, ai quali la chitarra pare ispirarsi, prima che l'intero brano venga rovinato da un irritante uso delle voci. Gold on the ceiling cerca di fondere le atmosfere hard blues degli esordi con squarci psichedelici e sonorità più moderne, in quello che alla fine risulta comunque essere un intrigante pastiche sonoro. Little black submarines pare arrivare dall'esordio solista di Auerbach, e prendendo spunto dalla zeppeliniana Stairway to heaven, ne ricalca l'impianto strumentale, iniziando quasi in sordina, acustica, per poi esplodere nel finale in un elettrico tourbillon sonoro. I vecchi Black Keys tornano nuovamente a fare capolino in Money maker, sporco ed incalzante garage rock, materia nella quale i nostri dimostrano ancora di saper eccellere, come peraltro ribadito dalla successiva Run right back, seppur penalizzata da ulteriori iniezioni moderniste. Hell of a season riprende in parte le sonorità di Lonely boy senza però possedere l'appeal di quest'ultima. Definire oscene Sister e Stop stop sarebbe far loro un complimento; la prima un hard funk senza capo nè coda, mentre la seconda è da ascrivere tra i brani più insulsi ascoltati quest'anno, complice anche un ritornello che sfocia verso certa faciloneria pop. Nova baby ha un che di strokesiano, rubacchiando a piene mani dal catalogo musicale di Casablancas e soci, risultando alla fin fine piacevole e poco più. La conclusiva Mind eraser nulla aggiunge e nulla toglie all'economia dell'album; un onesto e robusto rock dalle reminescenze blues, senza infamia nè lode. Quello che balza subito all'orecchio, dopo l'ascolto dell'intero disco, è tuttavia un generale appiattimento musicale, una banalizzazione della formula sonora che da sempre aveva caratterizzato l'opera del duo di Akron. Vittime sacrificali sono senza dubbio la voce e la chitarra di Auerbach, mai come in quest'occasione addomesticate, svuotate e tenute quasi a freno; così come l'operato dietro ai tamburi di Carney, il cui drumming tanto furioso quanto originale pare essere solo un lontano ricordo, sostituito da un insipido e scontato accompagnamento ritmico. Gran parte della colpa è, a mio avviso, da ascrivere all'operato, dietro al banco di regia, di Danger Mouse, il quale è riuscito ancora una volta a deturpare quello che potenzialmente poteva essere un disco più che discreto, seppur privo del carattere e della personalità dei primi lavori. Speriamo almeno che on stage i nostri riescano a far riemergere la loro primordiale e infuocata anima blues, da veri animali da palcoscenico quali sono. Sono comunque certo che El Camino saprà mietere consensi sia di critica che di pubblico, come peraltro testimoniato dal sold out dell'unica data italiana del duo. A chi scrive piace, malgrado ciò, ritornare con la mente agli inizi della favola del duo di Akron, quando i nostri erano ancora due giovani e imberbi ragazzi della profonda provincia americana, che giravano su di un vecchio furgone con la musica di Junior Kimbrough a tutto volume. E ora scusatemi, ma andrò ad ascoltarmi nuovamente quel piccolo gioiello che era e rimane Thickfreakness. lunedì 12 dicembre 2011
Mark W. Lennon - Home of the wheel
(Pubblicato su Rootshighway)
 E' proprio vero che spesso le più belle sorprese ce le riservano non nomi blasonati, ma giovani e sconosciuti talenti. A rafforzare ulteriormente questa mia convinzione giunge ora questo Home of the Wheel, opera prima di Mark W. Lennon. Nativo del North Carolina ma trasferitosi a Los Angeles, il nostro è quel che si dice un emerito sconosciuto, uno degli innumerevoli songwriters che affollano il panorama musicale americano, dai quali tuttavia riesce a distinguersi grazie ad una penna alquanto ispirata, già affinata con un precedente EP, Down the Mountain, datato 2009. E' però con questo suo primo full lenght che il cantautore ha la possibilità di mettere in luce tutte le sue qualità, a cominciare da una voce capace di infondere positività anche a composizioni intrise di tristezza e malinconia, alla quale si unisce un'accurata ricerca testuale che, prendendo spunto dalla propria storia familiare, traccia una sorta di ponte letterario tra gli anni della Grande Depressione e i giorni nostri. Arco temporale che viene setacciato anche dal punto di vista sonoro, andando ad attingere a quel vasto calderone musicale che è la musica americana, estrapolandone i tratti distintivi, con i quali comporre un variegato mosaico sonoro. Collante indispensabile per questo fine lavoro di cesellatura è Marvin Etzioni (già membro dei Lone Justice nonché produttore per artisti come Steve Earle e Lucinda Williams), il quale oltre a sedersi dietro al banco della regia, da il proprio contributo suonando mandolino, chitarra e piano. Un mosaico sonoro quello di Lennon che, partendo dal folk guthriano, attinge prima alla fonte del cantautorato dylaniano, per poi assorbire gli umori country del giovane Gram Parsons, fino ad arrivare a inglobare sonorità più prettamente moderniste e tendenti al rock. Prendiamo per esempio l'opener The River Stays the Same o la corale Cold Mountain Steel, le quali sembrano provenire dai solchi del capolavoro dylaniano Desire, complice anche la presenza del violino di Scarlett Rivera, che alla realizzazione di quel disco aveva preso parte. Home of the Wheel si sviluppa su di un parco arrangiamento acustico, lasciando ampia libertà d'espressione alla bella voce del nostro. California calling è invece country fino al midollo e fa sua la lezione impartita da Gram Parsons, con la steel guitar di Bryan Dobbs sugli scudi, e la delicata voce di Sally Jaye ad intrecciarsi con quella di Lennon. Blues Forever (In Your Eyes) entra di diritto tra le migliori ballate ascoltate quest'anno, semplice ma di grande fascino, così come Before the Fall, che ha dalla sua anche un azzeccato refrain. Dai toni più soffusi e scuri è Sad Songs, che partendo da un tappeto sonoro per soli contrabbasso e batteria, si apre nel finale grazie agli interventi di un liquido organo. La pianistica Look for the Walls, conquista per il suo andamento sgangherato, strizzando l'occhio a certe sonorità mainstream, senza però venirne sopraffatta. La tirata These times better, in odore di bluegrass, torna a correre lungo i binari della tradizione musicale americana, così come Paper Doll, per sola chitarra acustica e mandolino, nella quale il lato folkie di Lennon torna ad incantarci. C'è spazio anche per elementi tipicamente rock che vengono fatti confluire nella conclusiva Stop&Go. Un debutto coi fiocchi quindi, che lascia ben sperare per il futuro di un songwriter, del quale sono sicuro sentiremo ancora parlare.
E' proprio vero che spesso le più belle sorprese ce le riservano non nomi blasonati, ma giovani e sconosciuti talenti. A rafforzare ulteriormente questa mia convinzione giunge ora questo Home of the Wheel, opera prima di Mark W. Lennon. Nativo del North Carolina ma trasferitosi a Los Angeles, il nostro è quel che si dice un emerito sconosciuto, uno degli innumerevoli songwriters che affollano il panorama musicale americano, dai quali tuttavia riesce a distinguersi grazie ad una penna alquanto ispirata, già affinata con un precedente EP, Down the Mountain, datato 2009. E' però con questo suo primo full lenght che il cantautore ha la possibilità di mettere in luce tutte le sue qualità, a cominciare da una voce capace di infondere positività anche a composizioni intrise di tristezza e malinconia, alla quale si unisce un'accurata ricerca testuale che, prendendo spunto dalla propria storia familiare, traccia una sorta di ponte letterario tra gli anni della Grande Depressione e i giorni nostri. Arco temporale che viene setacciato anche dal punto di vista sonoro, andando ad attingere a quel vasto calderone musicale che è la musica americana, estrapolandone i tratti distintivi, con i quali comporre un variegato mosaico sonoro. Collante indispensabile per questo fine lavoro di cesellatura è Marvin Etzioni (già membro dei Lone Justice nonché produttore per artisti come Steve Earle e Lucinda Williams), il quale oltre a sedersi dietro al banco della regia, da il proprio contributo suonando mandolino, chitarra e piano. Un mosaico sonoro quello di Lennon che, partendo dal folk guthriano, attinge prima alla fonte del cantautorato dylaniano, per poi assorbire gli umori country del giovane Gram Parsons, fino ad arrivare a inglobare sonorità più prettamente moderniste e tendenti al rock. Prendiamo per esempio l'opener The River Stays the Same o la corale Cold Mountain Steel, le quali sembrano provenire dai solchi del capolavoro dylaniano Desire, complice anche la presenza del violino di Scarlett Rivera, che alla realizzazione di quel disco aveva preso parte. Home of the Wheel si sviluppa su di un parco arrangiamento acustico, lasciando ampia libertà d'espressione alla bella voce del nostro. California calling è invece country fino al midollo e fa sua la lezione impartita da Gram Parsons, con la steel guitar di Bryan Dobbs sugli scudi, e la delicata voce di Sally Jaye ad intrecciarsi con quella di Lennon. Blues Forever (In Your Eyes) entra di diritto tra le migliori ballate ascoltate quest'anno, semplice ma di grande fascino, così come Before the Fall, che ha dalla sua anche un azzeccato refrain. Dai toni più soffusi e scuri è Sad Songs, che partendo da un tappeto sonoro per soli contrabbasso e batteria, si apre nel finale grazie agli interventi di un liquido organo. La pianistica Look for the Walls, conquista per il suo andamento sgangherato, strizzando l'occhio a certe sonorità mainstream, senza però venirne sopraffatta. La tirata These times better, in odore di bluegrass, torna a correre lungo i binari della tradizione musicale americana, così come Paper Doll, per sola chitarra acustica e mandolino, nella quale il lato folkie di Lennon torna ad incantarci. C'è spazio anche per elementi tipicamente rock che vengono fatti confluire nella conclusiva Stop&Go. Un debutto coi fiocchi quindi, che lascia ben sperare per il futuro di un songwriter, del quale sono sicuro sentiremo ancora parlare.
 E' proprio vero che spesso le più belle sorprese ce le riservano non nomi blasonati, ma giovani e sconosciuti talenti. A rafforzare ulteriormente questa mia convinzione giunge ora questo Home of the Wheel, opera prima di Mark W. Lennon. Nativo del North Carolina ma trasferitosi a Los Angeles, il nostro è quel che si dice un emerito sconosciuto, uno degli innumerevoli songwriters che affollano il panorama musicale americano, dai quali tuttavia riesce a distinguersi grazie ad una penna alquanto ispirata, già affinata con un precedente EP, Down the Mountain, datato 2009. E' però con questo suo primo full lenght che il cantautore ha la possibilità di mettere in luce tutte le sue qualità, a cominciare da una voce capace di infondere positività anche a composizioni intrise di tristezza e malinconia, alla quale si unisce un'accurata ricerca testuale che, prendendo spunto dalla propria storia familiare, traccia una sorta di ponte letterario tra gli anni della Grande Depressione e i giorni nostri. Arco temporale che viene setacciato anche dal punto di vista sonoro, andando ad attingere a quel vasto calderone musicale che è la musica americana, estrapolandone i tratti distintivi, con i quali comporre un variegato mosaico sonoro. Collante indispensabile per questo fine lavoro di cesellatura è Marvin Etzioni (già membro dei Lone Justice nonché produttore per artisti come Steve Earle e Lucinda Williams), il quale oltre a sedersi dietro al banco della regia, da il proprio contributo suonando mandolino, chitarra e piano. Un mosaico sonoro quello di Lennon che, partendo dal folk guthriano, attinge prima alla fonte del cantautorato dylaniano, per poi assorbire gli umori country del giovane Gram Parsons, fino ad arrivare a inglobare sonorità più prettamente moderniste e tendenti al rock. Prendiamo per esempio l'opener The River Stays the Same o la corale Cold Mountain Steel, le quali sembrano provenire dai solchi del capolavoro dylaniano Desire, complice anche la presenza del violino di Scarlett Rivera, che alla realizzazione di quel disco aveva preso parte. Home of the Wheel si sviluppa su di un parco arrangiamento acustico, lasciando ampia libertà d'espressione alla bella voce del nostro. California calling è invece country fino al midollo e fa sua la lezione impartita da Gram Parsons, con la steel guitar di Bryan Dobbs sugli scudi, e la delicata voce di Sally Jaye ad intrecciarsi con quella di Lennon. Blues Forever (In Your Eyes) entra di diritto tra le migliori ballate ascoltate quest'anno, semplice ma di grande fascino, così come Before the Fall, che ha dalla sua anche un azzeccato refrain. Dai toni più soffusi e scuri è Sad Songs, che partendo da un tappeto sonoro per soli contrabbasso e batteria, si apre nel finale grazie agli interventi di un liquido organo. La pianistica Look for the Walls, conquista per il suo andamento sgangherato, strizzando l'occhio a certe sonorità mainstream, senza però venirne sopraffatta. La tirata These times better, in odore di bluegrass, torna a correre lungo i binari della tradizione musicale americana, così come Paper Doll, per sola chitarra acustica e mandolino, nella quale il lato folkie di Lennon torna ad incantarci. C'è spazio anche per elementi tipicamente rock che vengono fatti confluire nella conclusiva Stop&Go. Un debutto coi fiocchi quindi, che lascia ben sperare per il futuro di un songwriter, del quale sono sicuro sentiremo ancora parlare.
E' proprio vero che spesso le più belle sorprese ce le riservano non nomi blasonati, ma giovani e sconosciuti talenti. A rafforzare ulteriormente questa mia convinzione giunge ora questo Home of the Wheel, opera prima di Mark W. Lennon. Nativo del North Carolina ma trasferitosi a Los Angeles, il nostro è quel che si dice un emerito sconosciuto, uno degli innumerevoli songwriters che affollano il panorama musicale americano, dai quali tuttavia riesce a distinguersi grazie ad una penna alquanto ispirata, già affinata con un precedente EP, Down the Mountain, datato 2009. E' però con questo suo primo full lenght che il cantautore ha la possibilità di mettere in luce tutte le sue qualità, a cominciare da una voce capace di infondere positività anche a composizioni intrise di tristezza e malinconia, alla quale si unisce un'accurata ricerca testuale che, prendendo spunto dalla propria storia familiare, traccia una sorta di ponte letterario tra gli anni della Grande Depressione e i giorni nostri. Arco temporale che viene setacciato anche dal punto di vista sonoro, andando ad attingere a quel vasto calderone musicale che è la musica americana, estrapolandone i tratti distintivi, con i quali comporre un variegato mosaico sonoro. Collante indispensabile per questo fine lavoro di cesellatura è Marvin Etzioni (già membro dei Lone Justice nonché produttore per artisti come Steve Earle e Lucinda Williams), il quale oltre a sedersi dietro al banco della regia, da il proprio contributo suonando mandolino, chitarra e piano. Un mosaico sonoro quello di Lennon che, partendo dal folk guthriano, attinge prima alla fonte del cantautorato dylaniano, per poi assorbire gli umori country del giovane Gram Parsons, fino ad arrivare a inglobare sonorità più prettamente moderniste e tendenti al rock. Prendiamo per esempio l'opener The River Stays the Same o la corale Cold Mountain Steel, le quali sembrano provenire dai solchi del capolavoro dylaniano Desire, complice anche la presenza del violino di Scarlett Rivera, che alla realizzazione di quel disco aveva preso parte. Home of the Wheel si sviluppa su di un parco arrangiamento acustico, lasciando ampia libertà d'espressione alla bella voce del nostro. California calling è invece country fino al midollo e fa sua la lezione impartita da Gram Parsons, con la steel guitar di Bryan Dobbs sugli scudi, e la delicata voce di Sally Jaye ad intrecciarsi con quella di Lennon. Blues Forever (In Your Eyes) entra di diritto tra le migliori ballate ascoltate quest'anno, semplice ma di grande fascino, così come Before the Fall, che ha dalla sua anche un azzeccato refrain. Dai toni più soffusi e scuri è Sad Songs, che partendo da un tappeto sonoro per soli contrabbasso e batteria, si apre nel finale grazie agli interventi di un liquido organo. La pianistica Look for the Walls, conquista per il suo andamento sgangherato, strizzando l'occhio a certe sonorità mainstream, senza però venirne sopraffatta. La tirata These times better, in odore di bluegrass, torna a correre lungo i binari della tradizione musicale americana, così come Paper Doll, per sola chitarra acustica e mandolino, nella quale il lato folkie di Lennon torna ad incantarci. C'è spazio anche per elementi tipicamente rock che vengono fatti confluire nella conclusiva Stop&Go. Un debutto coi fiocchi quindi, che lascia ben sperare per il futuro di un songwriter, del quale sono sicuro sentiremo ancora parlare. lunedì 28 novembre 2011
Jennie Lowe Stearns - Blurry Edges
(Pubblicato su Rootshighway)
 Un'artista a tutto tondo Jennie Stearns, come ci conferma la sua ultima fatica discografica, Blurry Edges, album concepito e ultimato passo passo con una cura quasi maniacale verso ogni singolo dettaglio. A cominciare dalla produzione, che vede la nostra affiancarsi dietro al banco di regia ad Alex Perealis e al proprio tastierista Michael Stark, fino ad arrivare alla copertina, opera anch'essa dell'artista, dipinta durante la fase di missaggio del disco. Cura verso i dettagli che, unita a un pugno di canzoni intrise di atmosfere di chiara matrice folk, porta alla realizzazione di un album intenso ed affascinante. Ottima anche la scelta di sfruttare appieno, per la prima volta in studio, le potenzialità dei Fire Choir, band ormai solida e rodata, che solitamente accompagna l'artista dal vivo. Un suono, quello che pervade Blurry Edges, che attinge come dicevamo poc'anzi dalla tradizione folk americana, con un forte retrogusto country, tra lap steel, piano e chitarra acustica. Atmosfere soffuse quindi, che in alcuni casi si fanno quasi cupe, come nell'opener Shadow on the lake, ombrosa fin dal titolo, dal ritmo cadenzato, con il piano intento a contrappuntare con mirati ed affascinanti interventi la chitarra acustica della nostra. Pale blue parka è una piccola perla di rara bellezza, con una batteria spazzolata e un contrabbasso a dettare il ritmo, sul quale la voce quasi sussurrata della Stearns ben si amalgama con il controcanto di Emily Arin. Interpretazione vocale che rimane su livelli emozionali altissimi anche nelle successive e pianistiche Lose control e Frida, che hanno il pregio di esplorare il lato più cantautorale dell'artista. La lap steel di Joe Novelli ammanta di country le impalcature sonore di Grasp e Light of day, riportandoci in territori cari alla tradizione musicale americana. In from the cold è invece un piccolo e suggestivo acquarello acustico, dipinto da piano, chitarra e lap steel. Contrabbasso e batteria ci guidano nuovamente verso sonorità più tetre in Underwater dove restano ancora da segnalare gli ottimi incastri vocali tra le due voci femminili, con Stark che si destreggia da par suo al piano. Strumento quest'ultimo che torna protagonista nell'onirica Thieves, insieme alla batteria di Matt Sacucci Morano, percossa dolcemente con i mallets, creando così un alone sonoro sinuoso ed avvolgente.
Un'artista a tutto tondo Jennie Stearns, come ci conferma la sua ultima fatica discografica, Blurry Edges, album concepito e ultimato passo passo con una cura quasi maniacale verso ogni singolo dettaglio. A cominciare dalla produzione, che vede la nostra affiancarsi dietro al banco di regia ad Alex Perealis e al proprio tastierista Michael Stark, fino ad arrivare alla copertina, opera anch'essa dell'artista, dipinta durante la fase di missaggio del disco. Cura verso i dettagli che, unita a un pugno di canzoni intrise di atmosfere di chiara matrice folk, porta alla realizzazione di un album intenso ed affascinante. Ottima anche la scelta di sfruttare appieno, per la prima volta in studio, le potenzialità dei Fire Choir, band ormai solida e rodata, che solitamente accompagna l'artista dal vivo. Un suono, quello che pervade Blurry Edges, che attinge come dicevamo poc'anzi dalla tradizione folk americana, con un forte retrogusto country, tra lap steel, piano e chitarra acustica. Atmosfere soffuse quindi, che in alcuni casi si fanno quasi cupe, come nell'opener Shadow on the lake, ombrosa fin dal titolo, dal ritmo cadenzato, con il piano intento a contrappuntare con mirati ed affascinanti interventi la chitarra acustica della nostra. Pale blue parka è una piccola perla di rara bellezza, con una batteria spazzolata e un contrabbasso a dettare il ritmo, sul quale la voce quasi sussurrata della Stearns ben si amalgama con il controcanto di Emily Arin. Interpretazione vocale che rimane su livelli emozionali altissimi anche nelle successive e pianistiche Lose control e Frida, che hanno il pregio di esplorare il lato più cantautorale dell'artista. La lap steel di Joe Novelli ammanta di country le impalcature sonore di Grasp e Light of day, riportandoci in territori cari alla tradizione musicale americana. In from the cold è invece un piccolo e suggestivo acquarello acustico, dipinto da piano, chitarra e lap steel. Contrabbasso e batteria ci guidano nuovamente verso sonorità più tetre in Underwater dove restano ancora da segnalare gli ottimi incastri vocali tra le due voci femminili, con Stark che si destreggia da par suo al piano. Strumento quest'ultimo che torna protagonista nell'onirica Thieves, insieme alla batteria di Matt Sacucci Morano, percossa dolcemente con i mallets, creando così un alone sonoro sinuoso ed avvolgente.
 Un'artista a tutto tondo Jennie Stearns, come ci conferma la sua ultima fatica discografica, Blurry Edges, album concepito e ultimato passo passo con una cura quasi maniacale verso ogni singolo dettaglio. A cominciare dalla produzione, che vede la nostra affiancarsi dietro al banco di regia ad Alex Perealis e al proprio tastierista Michael Stark, fino ad arrivare alla copertina, opera anch'essa dell'artista, dipinta durante la fase di missaggio del disco. Cura verso i dettagli che, unita a un pugno di canzoni intrise di atmosfere di chiara matrice folk, porta alla realizzazione di un album intenso ed affascinante. Ottima anche la scelta di sfruttare appieno, per la prima volta in studio, le potenzialità dei Fire Choir, band ormai solida e rodata, che solitamente accompagna l'artista dal vivo. Un suono, quello che pervade Blurry Edges, che attinge come dicevamo poc'anzi dalla tradizione folk americana, con un forte retrogusto country, tra lap steel, piano e chitarra acustica. Atmosfere soffuse quindi, che in alcuni casi si fanno quasi cupe, come nell'opener Shadow on the lake, ombrosa fin dal titolo, dal ritmo cadenzato, con il piano intento a contrappuntare con mirati ed affascinanti interventi la chitarra acustica della nostra. Pale blue parka è una piccola perla di rara bellezza, con una batteria spazzolata e un contrabbasso a dettare il ritmo, sul quale la voce quasi sussurrata della Stearns ben si amalgama con il controcanto di Emily Arin. Interpretazione vocale che rimane su livelli emozionali altissimi anche nelle successive e pianistiche Lose control e Frida, che hanno il pregio di esplorare il lato più cantautorale dell'artista. La lap steel di Joe Novelli ammanta di country le impalcature sonore di Grasp e Light of day, riportandoci in territori cari alla tradizione musicale americana. In from the cold è invece un piccolo e suggestivo acquarello acustico, dipinto da piano, chitarra e lap steel. Contrabbasso e batteria ci guidano nuovamente verso sonorità più tetre in Underwater dove restano ancora da segnalare gli ottimi incastri vocali tra le due voci femminili, con Stark che si destreggia da par suo al piano. Strumento quest'ultimo che torna protagonista nell'onirica Thieves, insieme alla batteria di Matt Sacucci Morano, percossa dolcemente con i mallets, creando così un alone sonoro sinuoso ed avvolgente.
Un'artista a tutto tondo Jennie Stearns, come ci conferma la sua ultima fatica discografica, Blurry Edges, album concepito e ultimato passo passo con una cura quasi maniacale verso ogni singolo dettaglio. A cominciare dalla produzione, che vede la nostra affiancarsi dietro al banco di regia ad Alex Perealis e al proprio tastierista Michael Stark, fino ad arrivare alla copertina, opera anch'essa dell'artista, dipinta durante la fase di missaggio del disco. Cura verso i dettagli che, unita a un pugno di canzoni intrise di atmosfere di chiara matrice folk, porta alla realizzazione di un album intenso ed affascinante. Ottima anche la scelta di sfruttare appieno, per la prima volta in studio, le potenzialità dei Fire Choir, band ormai solida e rodata, che solitamente accompagna l'artista dal vivo. Un suono, quello che pervade Blurry Edges, che attinge come dicevamo poc'anzi dalla tradizione folk americana, con un forte retrogusto country, tra lap steel, piano e chitarra acustica. Atmosfere soffuse quindi, che in alcuni casi si fanno quasi cupe, come nell'opener Shadow on the lake, ombrosa fin dal titolo, dal ritmo cadenzato, con il piano intento a contrappuntare con mirati ed affascinanti interventi la chitarra acustica della nostra. Pale blue parka è una piccola perla di rara bellezza, con una batteria spazzolata e un contrabbasso a dettare il ritmo, sul quale la voce quasi sussurrata della Stearns ben si amalgama con il controcanto di Emily Arin. Interpretazione vocale che rimane su livelli emozionali altissimi anche nelle successive e pianistiche Lose control e Frida, che hanno il pregio di esplorare il lato più cantautorale dell'artista. La lap steel di Joe Novelli ammanta di country le impalcature sonore di Grasp e Light of day, riportandoci in territori cari alla tradizione musicale americana. In from the cold è invece un piccolo e suggestivo acquarello acustico, dipinto da piano, chitarra e lap steel. Contrabbasso e batteria ci guidano nuovamente verso sonorità più tetre in Underwater dove restano ancora da segnalare gli ottimi incastri vocali tra le due voci femminili, con Stark che si destreggia da par suo al piano. Strumento quest'ultimo che torna protagonista nell'onirica Thieves, insieme alla batteria di Matt Sacucci Morano, percossa dolcemente con i mallets, creando così un alone sonoro sinuoso ed avvolgente.
Alla title track, posta in chiusura, spetta invece il compito di condensare in un unico brano tutti gli elementi sonori precedentemente descritti. Parte quasi in sordina, come un'eterea ballata, per crescere d'intensità durante il suo svolgimento fino a sfociare nel finale verso derive elettriche cariche di feedback. Ne possiede di talento Jennie Stearns e qui viene espresso nella sua totalità, mostrandoci un'artista sicura dei propri mezzi e capace di scrivere canzoni dal peso specifico davvero notevole. Un consiglio spassionato, ascoltatelo durante una giornata piovosa, il cadere della pioggia accentuerà ulteriormente le atmosfere rarefatte del disco, per un'esperienza sonora che vi lascerà senza fiato.
giovedì 24 novembre 2011
Wilco - The whole love
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Sull’eclettismo musicale dei Wilco si potrebbe scrivere un trattato; basti solamente osservare il tragitto sonoro che i nostri hanno percorso a partire dal loro debutto fino ad arrivare al nuovo The Whole Love. Un lungo ed intenso viaggio in musica che a partire dalle atmosfere alternative country che permeavano il loro primo vagito in studio, ha portato il gruppo a reinventarsi disco dopo disco nel nome di una sperimentazione sonora che non ha conosciuto sosta.
Sull’eclettismo musicale dei Wilco si potrebbe scrivere un trattato; basti solamente osservare il tragitto sonoro che i nostri hanno percorso a partire dal loro debutto fino ad arrivare al nuovo The Whole Love. Un lungo ed intenso viaggio in musica che a partire dalle atmosfere alternative country che permeavano il loro primo vagito in studio, ha portato il gruppo a reinventarsi disco dopo disco nel nome di una sperimentazione sonora che non ha conosciuto sosta.
Merito senza dubbio del talento compositivo di Jeff Tweedy, a mio parere uno dei maggiori songwriter della sua generazione, nonché di un manipolo di musicisti eccelsi per inventiva e capacità tecniche, che ha trovato nell’inserimento in pianta stabile di Nels Cline e Glenn Kotche nuova linfa creativa. Un combo che ha fatto della ricerca sonora il suo credo, arrivando a toccare in passato vette di ineguagliabile bellezza. Ricerca capace di fondere tra di loro i generi più disparati; dal folk al country, fino ad arrivare all’alternative rock ed all’elettronica, uniti a un gusto per la melodia smaccatamente pop, il tutto in una miscela sonora difficilmente riscontrabile in altri gruppi dell’odierno panorama musicale. I Wilco rappresentano infatti un’entità a sé stante, lontana da catalogazioni o inserimenti in questa o quella scena, in quanto fautori di un sound capace, come accennato poc’anzi, di travalicare ogni confine musicale. A questo si aggiunge la recente creazione di una propria casa discografica, la dBpm per la quale viene pubblicato lo stesso The Whole Love, ulteriore segnale di un’ormai raggiunta indipendenza artistica. Prima di passare a trattare dell’aspetto prettamente musicale è doveroso soffermarsi sull’aspetto grafico dell’album. La versione deluxe di quest’ultimo è infatti particolarmente ricca e curata, merito senza dubbio di una lussuosa versione cartonata e di un corposo libretto contenente tutte le liriche e alcune splendide foto. L’occhio è pertanto sicuramente appagato ma ora è l’orecchio a reclamare la propria parte. Partiamo subito dicendo che The Whole Love non è un disco di facile fruizione, complice anche una stratificazione sonora piuttosto complessa unita ad un’eterogeneità di stili che si fa in questa occasione ancora più marcata rispetto al passato. Per farvi un’idea complessiva delle sonorità che troverete ivi contenute, immaginate di porre una carica esplosiva sotto la discografia wilconiana, e una volta fatta brillare quest’ultima di raccattarne i detriti sonori, componendo con essi un nuovo e intrigante mosaico musicale. Compito di aprire le danze spetta a quello che forse è il brano più sperimentale del lotto; Art Of Almost. Lunga, complessa, si sviluppa lentamente su più livelli, tra squarci elettronici, interventi orchestrali e reminescenze pop, in una sorta di calderone sonoro di grande suggestione. Scelta come singolo, I Might, cattura invece fin dal primo istante, con il suo incedere in bilico tra pop e rock, così come avviene nella pianistica Sunloathe e in Born Alone, dove riemerge il gusto per la melodia che da sempre contraddistingue i nostri. Black Moon e Open Mind ci riportano invece in territori cari al Jeff Tweedy più folk oriented, tra soffuse atmosfere acustiche, con la lapsteel di Nels Cline in primo piano. La swingata Capitol City ricorda in più di un frangente la produzione più scanzonata a marchio McCartney, nei bei vecchi tempi beatlesiani. Rising Red Lung è una nuova parentesi dai toni tenui, nella quale ampio spazio viene lasciato alle chitarre elettriche di Cline e Sansone, che avvolgono la suadente melodia opera della chitarra acustica di Tweedy. Dawned On Me e Standing O ricalcano invece quella formula sonora che ha reso celebre il gruppo, un intreccio tra sperimentalismo rock e armonie di matrice pop, che viene ripreso anche nella title track. La vera sorpresa arriva però in chiusura con la struggente acusticità di One Sunday Morning, disgressione musicale di dodici minuti, tra umori bucolici e derive in odore di psichedelia, per quella che è l’ennesima perla partorita dalla fervida mente di Tweedy. Nella versione deluxe possiamo inoltre trovare un secondo dischetto contenente alcune succose sorprese, che lascio a voi il piacere di scoprire.
The Whole Love è senza ombra di dubbio un nuovo splendido tassello di una discografia lastricata di piccoli grandi capolavori, e conferma una volta di più i Wilco come una delle più straordinarie rock band attualmente in circolazione.
The Whole Love è senza ombra di dubbio un nuovo splendido tassello di una discografia lastricata di piccoli grandi capolavori, e conferma una volta di più i Wilco come una delle più straordinarie rock band attualmente in circolazione.
mercoledì 23 novembre 2011
Watermelon Slim and Super Chikan - Okiesippi blues
Dopo tre ottimi album all’insegna del blues più sanguigno e viscerale, incensati dalla critica tanto da fare incetta di svariati premi, Bill Homans (aka Watermelon Slim), aveva spiazzato più di un ascoltatore, sottoscritto compreso, con un’improvvisa svolta verso sonorità country. Svolta che aveva portato alla pubblicazione di due dischi, Ringers e Escape from the chicken coop, di buona fattura ma senza dubbio inferiori ai loro predecessori. Ed è pertanto con un sorriso che ho accolto la notizia della pubblicazione di un nuovo album del nostro, in coppia con l’amico di lunga data James Johnson (aka Super Chikan). La coppia ha infatti approntato un lavoro che trasuda blues da ogni singola nota, scarno, essenziale ed ad alto tasso emotivo, come nella miglior tradizione del genere. Il blues è da sempre puro sentimento, musica che fluisce spontanea dal profondo dell’anima, e solo in pochi riescono a trasferire su pentagramma le intense emozioni legate ad esso. Di questa ristretta cerchia di musicisti fanno sicuramente parte i nostri eroi, che con questo Okiesippi blues, dimostrano una volta di più di saper egregiamente maneggiare la materia in questione. Queste due vecchie volpi hanno messo insieme una serie di pezzi, tra autografi e rivisitazioni, che trovano la loro forza nell’essenzialità sia a livello strumentale che di suono. Qui non troverete ensemble allargati, ospiti di lusso o debordanti divagazioni strumentali, ma solo due amici intenti a dialogare tra di loro con i propri strumenti. Ed è proprio un’atmosfera amichevole quella che si respira all’ascolto dell’album, una sorta di rimpatriata tra due vecchi compagni d’avventura che si ritrovano dopo tanto tempo e si raccontano le proprie esperienze di vita tramite un comune linguaggio, quello del blues. Basti prendere, per capire quanto detto poc’anzi, l’opener Trucking blues, dove è l’ipnotica chitarra di Super Chikan a condurre le danze, con Slim che soffia diligentemente nella propria armonica, e con le voci dei due che si alternano in una sorta di talking blues. Formula questa che viene ripresa e ulteriormente estremizzata anche in Northwest regional medical center blues, con Slim nel ruolo di narratore. I don’t wear no sunglasses vede salire nuovamente in cattedra quest’ultimo, per un torrido blues governato dalla chitarra slide, che rimanda ai gloriosi tempi dei primi dischi in compagnia dei Workers, con la voce di Slim, resa scura, cavernosa e roca dagli anni trascorsi a macinare chilometri lungo le highways americane, che assurge a vera protagonista. The trip è affidata invece alle sapienti dita di Super Chikan, che scorrono fluide e sicure sui tasti della chitarra, ed alla sua suadente e nera voce che sa conquistare fin dalla prima sillaba. I’m a little fish e You might know, dimostrano una volta di più come i nostri si trovino a proprio agio a suonare insieme e come la loro vena compositiva sia tutt’altro che inaridita. Dagli umori deltaici Moonshine vede nuovamente Johnson alla voce principale con Slim intento a fargli da contraltare prima con l’armonica e poi con la propria voce. Travolgente jam strumentale è invece Diddley-bo jam, dove i due si destreggiano ai rispettivi diddley-bow, strumento di origine africana ad una sola corda. Dal continente africano arriva anche la kalimba, con la quale Slim si cimenta in un’improbabile quanto riuscita rivisitazione di Within you without you, dal repertorio beatlesiano di George Harrison. Thou art with me, con le sue atmosfere acustiche ci riporta indietro nel tempo lungo le rive del Mississippi, sulla veranda di una vecchia baracca, sperduta in una delle immense piantagioni di cotone. Vero punto focale del disco è però la ripresa per sole voci e battito di mani e piedi di Keep your lamp trimmed and burning di mcdowelliana memoria, con Watermelon Slim istrionico maestro di cerimonie. Un disco fatto con classe, capacità e grande cuore, che è una fulgida testimonianza di quanto i nostri abbiano appreso dai loro viaggi musicali nella tradizione afroamericana.
venerdì 18 novembre 2011
Maria Muldaur - Steady love
(Pubblicato su Rootshighway)
 Per il suo nuovo album Maria Muldaur opta per un ritorno in un luogo a lei musicalmente molto caro, New Orleans. E proprio questa scelta influenza in modo più che positivo la realizzazione di Steady Love. Aiutata da un nugolo di esperti musicisti della Crescent City (tra i quali spiccano membri dei Neville Brothers e dei Subdudes) la Muldaur da infatti alle stampe un album che pare aver assorbito tutti gli aromi sonori che la città della Louisiana sa sprigionare. Un gumbo musicale a base di speziato blues, piccante swamp funk e dall'intenso retrogusto soul, in grado di unire egregiamente sacro e profano. Da sempre ottima interprete di brani altrui anche in questo caso la cantante sceglie con cura una serie di cover mai banali o scontate. E' il caso di I'll be glad, dal repertorio di Elvin Bishop, che apre egregiamente le danze, mostrandoci fin da subito quale sarà il tenore del disco. Uno shuffle che l'interpretazione vocale della Muldaur fa virare in territori vicini al soul, ricordando in alcuni frangenti quanto fatto recentemente da Mavis Staples. Why are people like that? è un sentito omaggio a una delle leggende della Louisiana, il mai troppo rimpianto Bobby Charles, e riesce a catturarne in modo egregio lo spirito musicale. Impetuosa è la ripresa di Soulful dress di Sugar Pie DeSanto, swamp venato di blues in cui la band gira a pieno regime e la voce della Muldaur graffia da par suo. Voce ancora protagonista nella trascinata Blues go walking, che arriva dalla prolifica penna di Greg Brown.
Per il suo nuovo album Maria Muldaur opta per un ritorno in un luogo a lei musicalmente molto caro, New Orleans. E proprio questa scelta influenza in modo più che positivo la realizzazione di Steady Love. Aiutata da un nugolo di esperti musicisti della Crescent City (tra i quali spiccano membri dei Neville Brothers e dei Subdudes) la Muldaur da infatti alle stampe un album che pare aver assorbito tutti gli aromi sonori che la città della Louisiana sa sprigionare. Un gumbo musicale a base di speziato blues, piccante swamp funk e dall'intenso retrogusto soul, in grado di unire egregiamente sacro e profano. Da sempre ottima interprete di brani altrui anche in questo caso la cantante sceglie con cura una serie di cover mai banali o scontate. E' il caso di I'll be glad, dal repertorio di Elvin Bishop, che apre egregiamente le danze, mostrandoci fin da subito quale sarà il tenore del disco. Uno shuffle che l'interpretazione vocale della Muldaur fa virare in territori vicini al soul, ricordando in alcuni frangenti quanto fatto recentemente da Mavis Staples. Why are people like that? è un sentito omaggio a una delle leggende della Louisiana, il mai troppo rimpianto Bobby Charles, e riesce a catturarne in modo egregio lo spirito musicale. Impetuosa è la ripresa di Soulful dress di Sugar Pie DeSanto, swamp venato di blues in cui la band gira a pieno regime e la voce della Muldaur graffia da par suo. Voce ancora protagonista nella trascinata Blues go walking, che arriva dalla prolifica penna di Greg Brown.
L'intensa rilettura del traditional I done made it up in my mind sfocia invece nel gospel, con la voce della nostra ben supportata da un coro preciso e puntuale, con la band che suona come se si trovasse davanti a una congregazione religiosa. Gospel, seppur venato di blues, che ritroviamo nella sempre meravigliosa Don't ever let nobody drag your spirit down, con un sapiente uso del "call and response". Ballata in odore di gospel è anche la tersa I am not alone con la chitarra di Rick Vito ad impreziosire il tutto e con la nostra impegnata a duettare con la figlia Jenny. Torna invece in primo piano il blues nello shuffle Get you next to me, e nei ritmi rallentati del sontuoso slow Rain down tears, ulteriore testimonianza della duttilità interpretativa della cantante. Conquista fin dal primo ascolto la titletrack, grazie anche al fondamentale apporto di una sezione fiati e di un liquido hammond, che rendono ancora più corposo il suono. L'invocativa Please send me someone to love sembra cucita addosso alla Muldaur, terreno ideale per la sua voce che la patina del tempo ha reso ancora più bluesy. Walk by faith, scritta dal compianto Stephen Bruton, unisce il fervore religioso del gospel con le atmosfere tribali della Crescent City. Un album decisamente riuscito quindi, grazie anche a una formula semplice quanto efficace; un pugno di brani, riarrangiati su misura per la Muldaur, e la voce di quest'ultima che fa la differenza.
venerdì 4 novembre 2011
Articolo su Levon Helm
(Pubblicato su Mixed Bag)
"We wound up in Woodstock, at an old time jamboree,
came to see the man behind the drums” (The man behind the drums – Robert Earl Keen)"
 Batterista, mandolinista e cantante solista in quel gruppo seminale che è stata la Band; già solamente questo potrebbe farci capire la caratura artistica di Levon Helm. Un’avventura irripetibile, che ha portato alla nascita delle radici di quella che oggi chiamiamo Americana. Nato ad Elaine in Arkansas, in un ambiente umile ed agreste, profondamente legato alla musica delle radici, Levon ha sempre cercato di raccontare la campagna, nella quale è cresciuto, e le storie, tra fatica e sofferenza, della sua gente. Ha intrapreso una carriera solista, con molte luci e poche ombre, attraverso la quale ha continuato ad esplorare i meandri più nascosti della tradizione musicale americana, bianca e nera. Levon Helm and RCO Allstars, primo vagito solista, vede la luce nel 1977 ed è l’ideale summa delle sue influenze musicali, un robusto rock blues in odore di tradizione, nel quale ad assurgere a vere protagoniste sono la sua batteria e la sua voce. Merito anche di una backing band a dir poco stellare, che annovera tra le sue fila tre-quarti degli Mg’s; Booker T Jones all’organo, Steve Cropper alla chitarra e Donald “Duck” Dunn al basso, ai quali si aggiungono Mac Rebennack alias Dr John al piano, Paul Butterfield all’armonica, Fred Carter Jr alla seconda chitarra nonché la sezione fiati del Saturday Night Live. Un album che allinea dieci canzoni pressoché perfette, dal rhythm and blues Washer woman con i fiati e l’armonica sugli scudi, alle travolgenti The tie that binds e Milk cow boogie, dove è il nostro a destreggiarsi sapientemente dietro ai tamburi. Le deliziose Blues so bad e Sing sing sing, hanno invece il pregio di confermare una volta di più le sue straordinarie capacità canore. Poco inferiore rispetto al debutto è Levon Helm , del 1978, in parte colpevole di ammiccare in più di un’occasione al rock patinato, come nell’opener Ain’t no way to forget you. Manca inoltre il parterre di stelle del precedente, ma il gruppo assemblato per l’occasione svolge dignitosamente il proprio compito. La riuscita Driving at night e la pianistica Playing something sweet, ricalcano le sonorità del disco precedente, mentre alquanto sottotono risultano Standing on a mountain top dall’incedere quasi reggae e la sapida I came here to party. Di notevole fattura sono invece Let do it in slow motion e Sweet Johanna, mentre Take me to the river, intrisa di soul fino al midollo, da sola varrebbe l’acquisto dell’album. Edito nel 1980, American son, riesce nell’intento di coniugare atmosfere rhythm and blues con elementi derivanti dalla tradizione musicale bianca. Apertura affidata a Watermelon time in Georgia, nella quale si respirano arie country folk, con Levon impegnato anche all’armonica. Un lavoro che alterna canzoni di valore (America’s farm dal retrogusto southern, Hurricane che richiama le sonorità della Band) riusciti episodi ( Blue house of broken hearts e il quasi shuffle Nashville wimmin) e qualche brano interlocutorio (China girl), per un album che, ancora oggi, risulta comunque fresco e godibile. Lo stesso anno il nostro debutta anche come attore, nel film Coal miner’s daughter, ottenendo critiche più che positive. Sarà questo il preludio ad una parallela carriera d’attore che lo vedrà recitare, anche se in ruoli secondari, in ben 16 film (ultimo dei quali In the electric mist del 2008, al fianco di Tommy Lee Jones). Nel 1982 viene dato alle stampe Levon Helm, decisamente meno riuscito rispetto al suo omonimo predecessore. Colpa soprattutto della pessima produzione, opera di Donald “Duck” Dunn, che ne snatura il suono, indirizzandolo verso tronfie atmosfere anni Ottanta. Qualche traccia salvabile la si potrebbe anche trovare, ma di brani memorabili non ve ne è traccia. Willie and the Hand Jive è passabile ma nulla più, e lo stesso vale per brani come You can’t win them all o Lucrecia, devastati da assurdi overdubs di chitarra e da una batteria filtrata da terrificanti echi e riverberi. Unica nota non stonata è la voce di Helm, capace come sempre di lasciare il segno. Un disco che rimane comunque il capitolo meno riuscito della discografia del batterista, e pertanto consigliato solo ai die hard fans. L’anno successivo la sua carriera da solista viene posta momentaneamente in standby, in favore della reunion della Band. Reunion che tra alterne riapparizioni e tre buoni album in studio, si protrarrà fino al 1996. Annus horribilis per Levon Helm è invece il 1998; al nostro viene diagnosticato un tumore alla gola, dal quale riuscirà comunque a guarire completamente, seppur con gravi danni alle corde vocali, che sembrano comprometterne definitivamente la carriera musicale. Il nuovo millennio riaccende invece la speranza; la sua voce migliora e, pur non ai livelli del passato, torna ad essere forte ed espressiva. È però l’incontro con Larry Campbell, eccelso polistrumentista, con una lunga militanza nella band di Dylan, a sancire la sua rinascita artistica. Nel 2004 prende il via una lunga serie di concerti che prendono il nome di Midnight Ramble Sessions, in ricordo degli antichi medicine show itineranti, ai quali partecipano artisti del calibro di Dr John, Black Crowes, Hot Tuna, Phil Lesh e molti altri. Due di queste straordinarie esibizioni verranno edite nel 2005 in due volumi separati. The Midnight Ramble vol I, ci mostra il profondo legame tra Levon Helm e la musica nera, e vede la presenza di Little Sammy Davis all’armonica. Una perfomance di rara intensità che arringa classici del blues come I’m ready, Blues with a feeling e Blow wind blow, riletti con sentimento e passione. Blues presente anche in The Midnight Ramble vol II, che amplia lo spettro sonoro del precedente inglobando robuste dosi di rock’n’roll e spruzzate di musica old time. Degne di menzione sono le riletture di Battle is over but the war goes on, della dylaniana Don’t ya tell Henry e della bluesata Blue shadows, nella quale compare Elvis Costello. Altro gradito ospite è il vecchio compagno Dr John, che in Borrowed time gigioneggia da par suo. Nello stesso periodo, viene pubblicata la registrazione di un vecchio concerto, effettuata pochi mesi dopo il suo debutto solista. Live at the Palladium NYC ci permette di assaporare la maestria della RCO Allstars Band anche on stage, con i brani del disco in studio che acquistano nuova linfa vitale. Le vere gemme sono però altre, a cominciare da una rilettura al fulmicotone di Goin’ back to Memphis, con il nostro a fare il buono e cattivo tempo dietro i tamburi. Ampio spazio viene anche lasciato agli altri musicisti, come in Born in Chicago, dove sono la voce e l’armonica di Paul Butterfield a salire in cattedra, o nella strepitosa versione del classico Got my mojo working, che Dr John trasforma in una sorta di rito voodoo. Ophelia omaggia il passato con la Band, mentre una scoppiettante versione di Goodnight Irene, di Huddie Ledbetter, chiude in bellezza la serata. Sotto l’egida di Larry Campbell, esce invece nel 2007, ad oltre venticinque anni di distanza dall’ultimo disco in studio, Dirt farmer. Un sentito tributo acustico alla musica delle radici, che si aggiudica il Grammy Awards come miglior album di folk tradizionale. Ad esso fa da contraltare il più muscolare Electric dirt (Grammy Awards come miglior album Americana), nel quale spiccano una sontuosa rilettura di Tennessee Jed di Jerry Garcia, il sentito omaggio a Muddy Waters con You can’t lose what you ain’t never had e la struggente e autografa Growin trade. Sarabanda musicale in puro New Orleans style è Kingfish, con i fiati arrangiati da Allen Toussiant, mentre When I go away, con i suoi intrecci vocali da brividi è il picco artistico dell’album. Il live Ramble at Ryman, registrato nel tempio della musica country, vede la presenza di ospiti illustri come John Hiatt, Buddy Miller, Sam Bush, Sheryl Crow, ed è l’ulteriore testimonianza di come, a 71 anni, Levon Helm stia vivendo una seconda giovinezza artistica.
Batterista, mandolinista e cantante solista in quel gruppo seminale che è stata la Band; già solamente questo potrebbe farci capire la caratura artistica di Levon Helm. Un’avventura irripetibile, che ha portato alla nascita delle radici di quella che oggi chiamiamo Americana. Nato ad Elaine in Arkansas, in un ambiente umile ed agreste, profondamente legato alla musica delle radici, Levon ha sempre cercato di raccontare la campagna, nella quale è cresciuto, e le storie, tra fatica e sofferenza, della sua gente. Ha intrapreso una carriera solista, con molte luci e poche ombre, attraverso la quale ha continuato ad esplorare i meandri più nascosti della tradizione musicale americana, bianca e nera. Levon Helm and RCO Allstars, primo vagito solista, vede la luce nel 1977 ed è l’ideale summa delle sue influenze musicali, un robusto rock blues in odore di tradizione, nel quale ad assurgere a vere protagoniste sono la sua batteria e la sua voce. Merito anche di una backing band a dir poco stellare, che annovera tra le sue fila tre-quarti degli Mg’s; Booker T Jones all’organo, Steve Cropper alla chitarra e Donald “Duck” Dunn al basso, ai quali si aggiungono Mac Rebennack alias Dr John al piano, Paul Butterfield all’armonica, Fred Carter Jr alla seconda chitarra nonché la sezione fiati del Saturday Night Live. Un album che allinea dieci canzoni pressoché perfette, dal rhythm and blues Washer woman con i fiati e l’armonica sugli scudi, alle travolgenti The tie that binds e Milk cow boogie, dove è il nostro a destreggiarsi sapientemente dietro ai tamburi. Le deliziose Blues so bad e Sing sing sing, hanno invece il pregio di confermare una volta di più le sue straordinarie capacità canore. Poco inferiore rispetto al debutto è Levon Helm , del 1978, in parte colpevole di ammiccare in più di un’occasione al rock patinato, come nell’opener Ain’t no way to forget you. Manca inoltre il parterre di stelle del precedente, ma il gruppo assemblato per l’occasione svolge dignitosamente il proprio compito. La riuscita Driving at night e la pianistica Playing something sweet, ricalcano le sonorità del disco precedente, mentre alquanto sottotono risultano Standing on a mountain top dall’incedere quasi reggae e la sapida I came here to party. Di notevole fattura sono invece Let do it in slow motion e Sweet Johanna, mentre Take me to the river, intrisa di soul fino al midollo, da sola varrebbe l’acquisto dell’album. Edito nel 1980, American son, riesce nell’intento di coniugare atmosfere rhythm and blues con elementi derivanti dalla tradizione musicale bianca. Apertura affidata a Watermelon time in Georgia, nella quale si respirano arie country folk, con Levon impegnato anche all’armonica. Un lavoro che alterna canzoni di valore (America’s farm dal retrogusto southern, Hurricane che richiama le sonorità della Band) riusciti episodi ( Blue house of broken hearts e il quasi shuffle Nashville wimmin) e qualche brano interlocutorio (China girl), per un album che, ancora oggi, risulta comunque fresco e godibile. Lo stesso anno il nostro debutta anche come attore, nel film Coal miner’s daughter, ottenendo critiche più che positive. Sarà questo il preludio ad una parallela carriera d’attore che lo vedrà recitare, anche se in ruoli secondari, in ben 16 film (ultimo dei quali In the electric mist del 2008, al fianco di Tommy Lee Jones). Nel 1982 viene dato alle stampe Levon Helm, decisamente meno riuscito rispetto al suo omonimo predecessore. Colpa soprattutto della pessima produzione, opera di Donald “Duck” Dunn, che ne snatura il suono, indirizzandolo verso tronfie atmosfere anni Ottanta. Qualche traccia salvabile la si potrebbe anche trovare, ma di brani memorabili non ve ne è traccia. Willie and the Hand Jive è passabile ma nulla più, e lo stesso vale per brani come You can’t win them all o Lucrecia, devastati da assurdi overdubs di chitarra e da una batteria filtrata da terrificanti echi e riverberi. Unica nota non stonata è la voce di Helm, capace come sempre di lasciare il segno. Un disco che rimane comunque il capitolo meno riuscito della discografia del batterista, e pertanto consigliato solo ai die hard fans. L’anno successivo la sua carriera da solista viene posta momentaneamente in standby, in favore della reunion della Band. Reunion che tra alterne riapparizioni e tre buoni album in studio, si protrarrà fino al 1996. Annus horribilis per Levon Helm è invece il 1998; al nostro viene diagnosticato un tumore alla gola, dal quale riuscirà comunque a guarire completamente, seppur con gravi danni alle corde vocali, che sembrano comprometterne definitivamente la carriera musicale. Il nuovo millennio riaccende invece la speranza; la sua voce migliora e, pur non ai livelli del passato, torna ad essere forte ed espressiva. È però l’incontro con Larry Campbell, eccelso polistrumentista, con una lunga militanza nella band di Dylan, a sancire la sua rinascita artistica. Nel 2004 prende il via una lunga serie di concerti che prendono il nome di Midnight Ramble Sessions, in ricordo degli antichi medicine show itineranti, ai quali partecipano artisti del calibro di Dr John, Black Crowes, Hot Tuna, Phil Lesh e molti altri. Due di queste straordinarie esibizioni verranno edite nel 2005 in due volumi separati. The Midnight Ramble vol I, ci mostra il profondo legame tra Levon Helm e la musica nera, e vede la presenza di Little Sammy Davis all’armonica. Una perfomance di rara intensità che arringa classici del blues come I’m ready, Blues with a feeling e Blow wind blow, riletti con sentimento e passione. Blues presente anche in The Midnight Ramble vol II, che amplia lo spettro sonoro del precedente inglobando robuste dosi di rock’n’roll e spruzzate di musica old time. Degne di menzione sono le riletture di Battle is over but the war goes on, della dylaniana Don’t ya tell Henry e della bluesata Blue shadows, nella quale compare Elvis Costello. Altro gradito ospite è il vecchio compagno Dr John, che in Borrowed time gigioneggia da par suo. Nello stesso periodo, viene pubblicata la registrazione di un vecchio concerto, effettuata pochi mesi dopo il suo debutto solista. Live at the Palladium NYC ci permette di assaporare la maestria della RCO Allstars Band anche on stage, con i brani del disco in studio che acquistano nuova linfa vitale. Le vere gemme sono però altre, a cominciare da una rilettura al fulmicotone di Goin’ back to Memphis, con il nostro a fare il buono e cattivo tempo dietro i tamburi. Ampio spazio viene anche lasciato agli altri musicisti, come in Born in Chicago, dove sono la voce e l’armonica di Paul Butterfield a salire in cattedra, o nella strepitosa versione del classico Got my mojo working, che Dr John trasforma in una sorta di rito voodoo. Ophelia omaggia il passato con la Band, mentre una scoppiettante versione di Goodnight Irene, di Huddie Ledbetter, chiude in bellezza la serata. Sotto l’egida di Larry Campbell, esce invece nel 2007, ad oltre venticinque anni di distanza dall’ultimo disco in studio, Dirt farmer. Un sentito tributo acustico alla musica delle radici, che si aggiudica il Grammy Awards come miglior album di folk tradizionale. Ad esso fa da contraltare il più muscolare Electric dirt (Grammy Awards come miglior album Americana), nel quale spiccano una sontuosa rilettura di Tennessee Jed di Jerry Garcia, il sentito omaggio a Muddy Waters con You can’t lose what you ain’t never had e la struggente e autografa Growin trade. Sarabanda musicale in puro New Orleans style è Kingfish, con i fiati arrangiati da Allen Toussiant, mentre When I go away, con i suoi intrecci vocali da brividi è il picco artistico dell’album. Il live Ramble at Ryman, registrato nel tempio della musica country, vede la presenza di ospiti illustri come John Hiatt, Buddy Miller, Sam Bush, Sheryl Crow, ed è l’ulteriore testimonianza di come, a 71 anni, Levon Helm stia vivendo una seconda giovinezza artistica.
"We wound up in Woodstock, at an old time jamboree,
came to see the man behind the drums” (The man behind the drums – Robert Earl Keen)"
 Batterista, mandolinista e cantante solista in quel gruppo seminale che è stata la Band; già solamente questo potrebbe farci capire la caratura artistica di Levon Helm. Un’avventura irripetibile, che ha portato alla nascita delle radici di quella che oggi chiamiamo Americana. Nato ad Elaine in Arkansas, in un ambiente umile ed agreste, profondamente legato alla musica delle radici, Levon ha sempre cercato di raccontare la campagna, nella quale è cresciuto, e le storie, tra fatica e sofferenza, della sua gente. Ha intrapreso una carriera solista, con molte luci e poche ombre, attraverso la quale ha continuato ad esplorare i meandri più nascosti della tradizione musicale americana, bianca e nera. Levon Helm and RCO Allstars, primo vagito solista, vede la luce nel 1977 ed è l’ideale summa delle sue influenze musicali, un robusto rock blues in odore di tradizione, nel quale ad assurgere a vere protagoniste sono la sua batteria e la sua voce. Merito anche di una backing band a dir poco stellare, che annovera tra le sue fila tre-quarti degli Mg’s; Booker T Jones all’organo, Steve Cropper alla chitarra e Donald “Duck” Dunn al basso, ai quali si aggiungono Mac Rebennack alias Dr John al piano, Paul Butterfield all’armonica, Fred Carter Jr alla seconda chitarra nonché la sezione fiati del Saturday Night Live. Un album che allinea dieci canzoni pressoché perfette, dal rhythm and blues Washer woman con i fiati e l’armonica sugli scudi, alle travolgenti The tie that binds e Milk cow boogie, dove è il nostro a destreggiarsi sapientemente dietro ai tamburi. Le deliziose Blues so bad e Sing sing sing, hanno invece il pregio di confermare una volta di più le sue straordinarie capacità canore. Poco inferiore rispetto al debutto è Levon Helm , del 1978, in parte colpevole di ammiccare in più di un’occasione al rock patinato, come nell’opener Ain’t no way to forget you. Manca inoltre il parterre di stelle del precedente, ma il gruppo assemblato per l’occasione svolge dignitosamente il proprio compito. La riuscita Driving at night e la pianistica Playing something sweet, ricalcano le sonorità del disco precedente, mentre alquanto sottotono risultano Standing on a mountain top dall’incedere quasi reggae e la sapida I came here to party. Di notevole fattura sono invece Let do it in slow motion e Sweet Johanna, mentre Take me to the river, intrisa di soul fino al midollo, da sola varrebbe l’acquisto dell’album. Edito nel 1980, American son, riesce nell’intento di coniugare atmosfere rhythm and blues con elementi derivanti dalla tradizione musicale bianca. Apertura affidata a Watermelon time in Georgia, nella quale si respirano arie country folk, con Levon impegnato anche all’armonica. Un lavoro che alterna canzoni di valore (America’s farm dal retrogusto southern, Hurricane che richiama le sonorità della Band) riusciti episodi ( Blue house of broken hearts e il quasi shuffle Nashville wimmin) e qualche brano interlocutorio (China girl), per un album che, ancora oggi, risulta comunque fresco e godibile. Lo stesso anno il nostro debutta anche come attore, nel film Coal miner’s daughter, ottenendo critiche più che positive. Sarà questo il preludio ad una parallela carriera d’attore che lo vedrà recitare, anche se in ruoli secondari, in ben 16 film (ultimo dei quali In the electric mist del 2008, al fianco di Tommy Lee Jones). Nel 1982 viene dato alle stampe Levon Helm, decisamente meno riuscito rispetto al suo omonimo predecessore. Colpa soprattutto della pessima produzione, opera di Donald “Duck” Dunn, che ne snatura il suono, indirizzandolo verso tronfie atmosfere anni Ottanta. Qualche traccia salvabile la si potrebbe anche trovare, ma di brani memorabili non ve ne è traccia. Willie and the Hand Jive è passabile ma nulla più, e lo stesso vale per brani come You can’t win them all o Lucrecia, devastati da assurdi overdubs di chitarra e da una batteria filtrata da terrificanti echi e riverberi. Unica nota non stonata è la voce di Helm, capace come sempre di lasciare il segno. Un disco che rimane comunque il capitolo meno riuscito della discografia del batterista, e pertanto consigliato solo ai die hard fans. L’anno successivo la sua carriera da solista viene posta momentaneamente in standby, in favore della reunion della Band. Reunion che tra alterne riapparizioni e tre buoni album in studio, si protrarrà fino al 1996. Annus horribilis per Levon Helm è invece il 1998; al nostro viene diagnosticato un tumore alla gola, dal quale riuscirà comunque a guarire completamente, seppur con gravi danni alle corde vocali, che sembrano comprometterne definitivamente la carriera musicale. Il nuovo millennio riaccende invece la speranza; la sua voce migliora e, pur non ai livelli del passato, torna ad essere forte ed espressiva. È però l’incontro con Larry Campbell, eccelso polistrumentista, con una lunga militanza nella band di Dylan, a sancire la sua rinascita artistica. Nel 2004 prende il via una lunga serie di concerti che prendono il nome di Midnight Ramble Sessions, in ricordo degli antichi medicine show itineranti, ai quali partecipano artisti del calibro di Dr John, Black Crowes, Hot Tuna, Phil Lesh e molti altri. Due di queste straordinarie esibizioni verranno edite nel 2005 in due volumi separati. The Midnight Ramble vol I, ci mostra il profondo legame tra Levon Helm e la musica nera, e vede la presenza di Little Sammy Davis all’armonica. Una perfomance di rara intensità che arringa classici del blues come I’m ready, Blues with a feeling e Blow wind blow, riletti con sentimento e passione. Blues presente anche in The Midnight Ramble vol II, che amplia lo spettro sonoro del precedente inglobando robuste dosi di rock’n’roll e spruzzate di musica old time. Degne di menzione sono le riletture di Battle is over but the war goes on, della dylaniana Don’t ya tell Henry e della bluesata Blue shadows, nella quale compare Elvis Costello. Altro gradito ospite è il vecchio compagno Dr John, che in Borrowed time gigioneggia da par suo. Nello stesso periodo, viene pubblicata la registrazione di un vecchio concerto, effettuata pochi mesi dopo il suo debutto solista. Live at the Palladium NYC ci permette di assaporare la maestria della RCO Allstars Band anche on stage, con i brani del disco in studio che acquistano nuova linfa vitale. Le vere gemme sono però altre, a cominciare da una rilettura al fulmicotone di Goin’ back to Memphis, con il nostro a fare il buono e cattivo tempo dietro i tamburi. Ampio spazio viene anche lasciato agli altri musicisti, come in Born in Chicago, dove sono la voce e l’armonica di Paul Butterfield a salire in cattedra, o nella strepitosa versione del classico Got my mojo working, che Dr John trasforma in una sorta di rito voodoo. Ophelia omaggia il passato con la Band, mentre una scoppiettante versione di Goodnight Irene, di Huddie Ledbetter, chiude in bellezza la serata. Sotto l’egida di Larry Campbell, esce invece nel 2007, ad oltre venticinque anni di distanza dall’ultimo disco in studio, Dirt farmer. Un sentito tributo acustico alla musica delle radici, che si aggiudica il Grammy Awards come miglior album di folk tradizionale. Ad esso fa da contraltare il più muscolare Electric dirt (Grammy Awards come miglior album Americana), nel quale spiccano una sontuosa rilettura di Tennessee Jed di Jerry Garcia, il sentito omaggio a Muddy Waters con You can’t lose what you ain’t never had e la struggente e autografa Growin trade. Sarabanda musicale in puro New Orleans style è Kingfish, con i fiati arrangiati da Allen Toussiant, mentre When I go away, con i suoi intrecci vocali da brividi è il picco artistico dell’album. Il live Ramble at Ryman, registrato nel tempio della musica country, vede la presenza di ospiti illustri come John Hiatt, Buddy Miller, Sam Bush, Sheryl Crow, ed è l’ulteriore testimonianza di come, a 71 anni, Levon Helm stia vivendo una seconda giovinezza artistica.
Batterista, mandolinista e cantante solista in quel gruppo seminale che è stata la Band; già solamente questo potrebbe farci capire la caratura artistica di Levon Helm. Un’avventura irripetibile, che ha portato alla nascita delle radici di quella che oggi chiamiamo Americana. Nato ad Elaine in Arkansas, in un ambiente umile ed agreste, profondamente legato alla musica delle radici, Levon ha sempre cercato di raccontare la campagna, nella quale è cresciuto, e le storie, tra fatica e sofferenza, della sua gente. Ha intrapreso una carriera solista, con molte luci e poche ombre, attraverso la quale ha continuato ad esplorare i meandri più nascosti della tradizione musicale americana, bianca e nera. Levon Helm and RCO Allstars, primo vagito solista, vede la luce nel 1977 ed è l’ideale summa delle sue influenze musicali, un robusto rock blues in odore di tradizione, nel quale ad assurgere a vere protagoniste sono la sua batteria e la sua voce. Merito anche di una backing band a dir poco stellare, che annovera tra le sue fila tre-quarti degli Mg’s; Booker T Jones all’organo, Steve Cropper alla chitarra e Donald “Duck” Dunn al basso, ai quali si aggiungono Mac Rebennack alias Dr John al piano, Paul Butterfield all’armonica, Fred Carter Jr alla seconda chitarra nonché la sezione fiati del Saturday Night Live. Un album che allinea dieci canzoni pressoché perfette, dal rhythm and blues Washer woman con i fiati e l’armonica sugli scudi, alle travolgenti The tie that binds e Milk cow boogie, dove è il nostro a destreggiarsi sapientemente dietro ai tamburi. Le deliziose Blues so bad e Sing sing sing, hanno invece il pregio di confermare una volta di più le sue straordinarie capacità canore. Poco inferiore rispetto al debutto è Levon Helm , del 1978, in parte colpevole di ammiccare in più di un’occasione al rock patinato, come nell’opener Ain’t no way to forget you. Manca inoltre il parterre di stelle del precedente, ma il gruppo assemblato per l’occasione svolge dignitosamente il proprio compito. La riuscita Driving at night e la pianistica Playing something sweet, ricalcano le sonorità del disco precedente, mentre alquanto sottotono risultano Standing on a mountain top dall’incedere quasi reggae e la sapida I came here to party. Di notevole fattura sono invece Let do it in slow motion e Sweet Johanna, mentre Take me to the river, intrisa di soul fino al midollo, da sola varrebbe l’acquisto dell’album. Edito nel 1980, American son, riesce nell’intento di coniugare atmosfere rhythm and blues con elementi derivanti dalla tradizione musicale bianca. Apertura affidata a Watermelon time in Georgia, nella quale si respirano arie country folk, con Levon impegnato anche all’armonica. Un lavoro che alterna canzoni di valore (America’s farm dal retrogusto southern, Hurricane che richiama le sonorità della Band) riusciti episodi ( Blue house of broken hearts e il quasi shuffle Nashville wimmin) e qualche brano interlocutorio (China girl), per un album che, ancora oggi, risulta comunque fresco e godibile. Lo stesso anno il nostro debutta anche come attore, nel film Coal miner’s daughter, ottenendo critiche più che positive. Sarà questo il preludio ad una parallela carriera d’attore che lo vedrà recitare, anche se in ruoli secondari, in ben 16 film (ultimo dei quali In the electric mist del 2008, al fianco di Tommy Lee Jones). Nel 1982 viene dato alle stampe Levon Helm, decisamente meno riuscito rispetto al suo omonimo predecessore. Colpa soprattutto della pessima produzione, opera di Donald “Duck” Dunn, che ne snatura il suono, indirizzandolo verso tronfie atmosfere anni Ottanta. Qualche traccia salvabile la si potrebbe anche trovare, ma di brani memorabili non ve ne è traccia. Willie and the Hand Jive è passabile ma nulla più, e lo stesso vale per brani come You can’t win them all o Lucrecia, devastati da assurdi overdubs di chitarra e da una batteria filtrata da terrificanti echi e riverberi. Unica nota non stonata è la voce di Helm, capace come sempre di lasciare il segno. Un disco che rimane comunque il capitolo meno riuscito della discografia del batterista, e pertanto consigliato solo ai die hard fans. L’anno successivo la sua carriera da solista viene posta momentaneamente in standby, in favore della reunion della Band. Reunion che tra alterne riapparizioni e tre buoni album in studio, si protrarrà fino al 1996. Annus horribilis per Levon Helm è invece il 1998; al nostro viene diagnosticato un tumore alla gola, dal quale riuscirà comunque a guarire completamente, seppur con gravi danni alle corde vocali, che sembrano comprometterne definitivamente la carriera musicale. Il nuovo millennio riaccende invece la speranza; la sua voce migliora e, pur non ai livelli del passato, torna ad essere forte ed espressiva. È però l’incontro con Larry Campbell, eccelso polistrumentista, con una lunga militanza nella band di Dylan, a sancire la sua rinascita artistica. Nel 2004 prende il via una lunga serie di concerti che prendono il nome di Midnight Ramble Sessions, in ricordo degli antichi medicine show itineranti, ai quali partecipano artisti del calibro di Dr John, Black Crowes, Hot Tuna, Phil Lesh e molti altri. Due di queste straordinarie esibizioni verranno edite nel 2005 in due volumi separati. The Midnight Ramble vol I, ci mostra il profondo legame tra Levon Helm e la musica nera, e vede la presenza di Little Sammy Davis all’armonica. Una perfomance di rara intensità che arringa classici del blues come I’m ready, Blues with a feeling e Blow wind blow, riletti con sentimento e passione. Blues presente anche in The Midnight Ramble vol II, che amplia lo spettro sonoro del precedente inglobando robuste dosi di rock’n’roll e spruzzate di musica old time. Degne di menzione sono le riletture di Battle is over but the war goes on, della dylaniana Don’t ya tell Henry e della bluesata Blue shadows, nella quale compare Elvis Costello. Altro gradito ospite è il vecchio compagno Dr John, che in Borrowed time gigioneggia da par suo. Nello stesso periodo, viene pubblicata la registrazione di un vecchio concerto, effettuata pochi mesi dopo il suo debutto solista. Live at the Palladium NYC ci permette di assaporare la maestria della RCO Allstars Band anche on stage, con i brani del disco in studio che acquistano nuova linfa vitale. Le vere gemme sono però altre, a cominciare da una rilettura al fulmicotone di Goin’ back to Memphis, con il nostro a fare il buono e cattivo tempo dietro i tamburi. Ampio spazio viene anche lasciato agli altri musicisti, come in Born in Chicago, dove sono la voce e l’armonica di Paul Butterfield a salire in cattedra, o nella strepitosa versione del classico Got my mojo working, che Dr John trasforma in una sorta di rito voodoo. Ophelia omaggia il passato con la Band, mentre una scoppiettante versione di Goodnight Irene, di Huddie Ledbetter, chiude in bellezza la serata. Sotto l’egida di Larry Campbell, esce invece nel 2007, ad oltre venticinque anni di distanza dall’ultimo disco in studio, Dirt farmer. Un sentito tributo acustico alla musica delle radici, che si aggiudica il Grammy Awards come miglior album di folk tradizionale. Ad esso fa da contraltare il più muscolare Electric dirt (Grammy Awards come miglior album Americana), nel quale spiccano una sontuosa rilettura di Tennessee Jed di Jerry Garcia, il sentito omaggio a Muddy Waters con You can’t lose what you ain’t never had e la struggente e autografa Growin trade. Sarabanda musicale in puro New Orleans style è Kingfish, con i fiati arrangiati da Allen Toussiant, mentre When I go away, con i suoi intrecci vocali da brividi è il picco artistico dell’album. Il live Ramble at Ryman, registrato nel tempio della musica country, vede la presenza di ospiti illustri come John Hiatt, Buddy Miller, Sam Bush, Sheryl Crow, ed è l’ulteriore testimonianza di come, a 71 anni, Levon Helm stia vivendo una seconda giovinezza artistica.
DIRT FARMER
Vanguard
2007
Venticinque lunghi anni, tanto è passato dall’ultima prova in studio di Levon Helm. Un ritorno in sala d’incisione quasi insperato visto il cancro alla gola che lo aveva colpito, compromettendone in parte la voce. Una voce, che seppur minata in potenza, torna a regalare intense emozioni. Un piccolo capolavoro acustico questo Dirt farmer, un sentito omaggio alle proprie radici musicali, andando a scavare all’interno della tradizione americana. Intrisa di atmosfere agresti, la quasi bluegrass False hearted blues, ci fa capire da subito la caratura del disco, con la voce del nostro in primo piano. Trasuda tradizione Poor old dirt farmer, con il violino di Larry Campbell e l’accordion di Brian Mitchell a tracciare la melodia, sulla quale si stagliano la voce di Levon, ed i cori della figlia Amy e di Teresa Williams, per un brano dal testo forte e impegnato. Ottima si rivela la rilettura di The mountain, dal songbook di Steve Earle, brano che pare scritto per il nostro, che lo canta con passione e trasporto. The train a robbery e Got me a woman, giocano con la tradizione, tra atmosfere old time, con Helm che si destreggia nell’ultima al mandolino. Feeling good è invece un omaggio a JB Lenoir e al blues tanto amato dal batterista. Calvary, scritta dal bassista Byron Isaacs, non sfigura in mezzo ai tradizionali, merito anche di un’interpretazione maiuscola del nostro. Le struggenti Little birds e Anna Lee impressionano invece per semplicità e vedono nel violino lo strumento guida. Due brani sofferti dove la voce di Helm raggiunge picchi d’intensità emotiva prima mai sfiorati. Chiude il disco la tersa Wide river to cross, scritta da Buddy Miller. Un album che omaggia le proprie radici e il proprio passato con cuore e passione e sancisce il ritorno di uno dei più straordinari interpreti della tradizione musicale americana.
William Elliott Whitmore - Field songs
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Esiste un’America profondamente innamorata delle proprie radici musicali; un manipolo di musicisti che rivolgono il proprio sguardo a musiche del passato, attualizzandole, innervandone il suono con nuova energia. Old Crow Medicine Show, Carolina Chocolate Drops, Gillian Welch e Dave Rawlings, sono solo alcuni nomi di questa sempre più nutrita cerchia di revivalisti, alla quale appartiene a tutti gli effetti anche William Elliott Whitmore.
Esiste un’America profondamente innamorata delle proprie radici musicali; un manipolo di musicisti che rivolgono il proprio sguardo a musiche del passato, attualizzandole, innervandone il suono con nuova energia. Old Crow Medicine Show, Carolina Chocolate Drops, Gillian Welch e Dave Rawlings, sono solo alcuni nomi di questa sempre più nutrita cerchia di revivalisti, alla quale appartiene a tutti gli effetti anche William Elliott Whitmore.
 Esiste un’America profondamente innamorata delle proprie radici musicali; un manipolo di musicisti che rivolgono il proprio sguardo a musiche del passato, attualizzandole, innervandone il suono con nuova energia. Old Crow Medicine Show, Carolina Chocolate Drops, Gillian Welch e Dave Rawlings, sono solo alcuni nomi di questa sempre più nutrita cerchia di revivalisti, alla quale appartiene a tutti gli effetti anche William Elliott Whitmore.
Esiste un’America profondamente innamorata delle proprie radici musicali; un manipolo di musicisti che rivolgono il proprio sguardo a musiche del passato, attualizzandole, innervandone il suono con nuova energia. Old Crow Medicine Show, Carolina Chocolate Drops, Gillian Welch e Dave Rawlings, sono solo alcuni nomi di questa sempre più nutrita cerchia di revivalisti, alla quale appartiene a tutti gli effetti anche William Elliott Whitmore.
Cresciuto in una comune punk, il nostro ha sempre cercato, nei suoi dischi, di inglobare la tradizione musicale afroamericana, fondendola con elementi prettamente moderni. Ne è nata una formula sonora, accattivante e di grande suggestione, che ha visto nel precedente Animals In The Dark la sintesi perfetta di questo connubio tra tradizione e modernità. Ritiratosi in una piccola fattoria, a Montrose, nello sperduto e natio stato dell’Iowa, Whitmore si dedica oggi, oltre che alla musica, anche al lavoro nei campi. Una vita dura e faticosa, capace di avvicinarlo ulteriormente alle proprie radici musicali, a quel blues prebellico e a quel folk che risuonavano nelle campagne nei primi decenni del secolo scorso. E proprio da questo ambiente agreste sono scaturite otto piccole gemme; otto composizioni dal sapore antico, che compongono Field Songs, sua ultima, stupenda fatica discografica. Whitmore ha più volte dichiarato di essersi voluto identificare attraverso queste canzoni, con tutte quelle persone che nel mondo faticano per sopravvivere; gente reale che si alza al mattino e fa il proprio lavoro senza lamentarsi e senza arrendersi mai. Parole che descrivono perfettamente la profonda valenza socio-musicale di Field Songs, ricordando quelle utilizzate in passato da Woody Guthrie, il più grande folk singer di sempre, per descrivere le proprie composizioni. Ed è proprio l’analogia con il cantore di Okemah, quella che balza all’orecchio. Le liriche sono, infatti, per entrambi parte fondamentale della composizione, in quanto capaci di risvegliare le coscienze, mettendo in luce soprusi e ingiustizie.
E in Field Songs la scrittura di Whitmore raggiunge livelli altissimi, narrando vicende e storie nelle quali ognuno di noi può identificarsi. Storie di sudore, rabbia e dolore, di un’umanità spesso senza voce, ma che vive e lotta ogni giorno con tutta la propria forza. Argomenti tremendamente attuali, che il nostro canta con un trasporto e con un’anima difficilmente ritrovabile in molti dei suoi colleghi incensati dalla critica. E proprio la voce di Whitmore ha ruolo preponderante nell’economia sonora del disco; una voce rauca, scura, profondamente nera, che ti penetra dentro rivoltandoti l’anima. Una voce che spicca per liricità su di un impianto musicale scarno e acustico, nel quale sono il banjo e la chitarra a dettare i ritmi, con una grancassa che compare in un paio d’occasioni.
Registrato in solitario e in presa diretta Field Songs sembra far parte delle registrazioni effettuate sul campo da John e Alan Lomax negli anni ’30. A questo si aggiungono delle vere e proprie field recordings, ad opera dello stesso Whitmore, registrate nei dintorni della propria fattoria, che ci accompagnano dalla prima canzone (il canto di un gallo) all’ultima (il gracidio delle rane e il frinire dei grilli), in una sorta di metaforico viaggio attraverso una giornata di duro lavoro nei campi. Ed è proprio questa l’aria che si respira all’ascolto del disco, tra forti sapori blues, folk bucolico e canti di lavoro, che caratterizzavano nel passato la vita agreste. Atmosfere old time delle quali è permeata Bury Your Burdens In The Ground, intrisa della struggente liricità del gospel con il banjo a tessere la linea ritmica e melodica, che ci invita a seppellire i nostri fardelli e continuare la nostra vita imparando dagli errori commessi. Field Song sembra invece provenire da un campo di cotone, una sorta di holler del nuovo millennio, con la voce di Whitmore che si fa scura, rauca, per un’interpretazione al limite della sofferenza. Sofferenza che ritroviamo nelle drammaticità di Don’t Need It, in odore di blues, dove fa la sua comparsa una chitarra elettrica, unica concessione modernista dell’intero lavoro. Di rara intensità è la successiva Everything Gets Gone, tersa ballata per sola voce e chitarra, nella miglior tradizione del folk statunitense. Il banjo di Let’s Do Something Impossibile ci riporta nuovamente ad atmosfere arcaiche e rurali, diretta discendente della musica dei Monti Appalachi. Utopica e sognante è Get There From Here, mentre ritroviamo nuovamente elementi cari al gospel in We’ll Carry On, che incanta tra speranza e sogni per un futuro migliore. Chiude il disco la magnifica Not Feeling Any Pain, ben rappresentativa della caratura artistica dell’intero lavoro.
In Field Songs Whitmore è riuscito a far emergere, ancor più che in passato, il proprio talento compositivo e interpretativo, confermandosi come uno dei più validi e sinceri prosecutori di una tradizione musicale ancora vitale. Sono sicuro che da lassù il buon vecchio Woody starà sorridendo soddisfatto.
Ry Cooder - Pull up some dust and sit down
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Alla soglia dei 65 anni Ry Cooder non finisce di stupire. Dopo una straordinaria carriera contraddistinta dalla ricerca etno-musicologica, il chitarrista decide di scrivere canzoni vere, canzoni per la gente. Pull Up Some Dust And Sit Down, da un modo di dire degli anni Trenta, è una sorta di invito alla conversazione, a fermarsi a pensare. Ed è proprio a quegli anni che il nostro ha rivolto lo sguardo, agli anni della Grande Depressione, anni di lotta, sofferenza e disillusione. Tematiche purtroppo ancora attuali, in una società nella quale il gap tra ricchi e poveri si va ulteriormente allargando. I tempi sono difficili e Cooder ha deciso di far sentire la propria voce, come Woody Guthrie, Pete Seeger e molti altri avevano fatto prima di lui. Per farlo chiama a se, oltre al figlio Joachim, alcuni vecchi e fidati pards, come l’immortale Flaco Jimenez, Terry Evans, Willie Green, Arnold McCuller e Jim Keltner, approntando un disco di protesta forte e vigoroso, tra folk, blues e musica messicana, composto da 14 canzoni che sono altrettante urla di rabbia e dolore. Un esempio è la feroce Quicksand, già pubblicata prima dell’uscita del disco su I-Tunes, che si scaglia contro le repressive leggi anti immigrazione dello stato dell’Arizona, e i cui proventi verranno destinati al MALDEF (acronimo di Mexican American Legal Defense And Education Fund) che cerca di proteggere i diritti degli immigrati messicani. Alla marcia di stampo folk No Banker Left Behind spetta invece il compito di aprire l’album, e rievocando il titolo di un articolo apparso sul settimanale Truthdig, se la prende con le banche e lo strozzinaggio legalizzato, veri e propri cancri dell’economia mondiale. El corrido de Jesse James è puro mexican style, un armonioso valzer dove la protagonista indiscussa è la fisarmonica di Jimenez, ben sostenuta dai fiati della 10 Banda. Atmosfere messicane che pervadono anche l’incalzante Christmas Time This Year, che attinge dalla più pura tradizione nortena. Dirty Chateau e Baby Joined The Army sono due toccanti ed intense ballate; nella prima fanno la loro comparsa anche dei violini, mentre nella seconda troviamo il nostro impegnato a destreggiarsi in solitario con la propria chitarra. Humpty Dumpty World pare uscita da uno dei suoi primi lavori, riprendendo quegli stilemi sonori che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Lord Tell Me Why è una sorta di gospel post apocalittico, con la batteria di Jim Keltner a dettare il ritmo e con un sapiente uso del call and response grazie anche all’apporto delle voci di Terry Evans, Arnold McCuller e Willie Green. Waitisiana per sonorità e interpretazione è invece la rabbiosa e convulsa I Want My Crown, con il nostro quasi diabolico alla voce. Entriamo in territorio blues con John Lee Hooker For President, dove Cooder ci narra cosa sarebbe potuto accadere se John Lee Hooker fosse diventato presidente degli Stati Uniti, riprendendo musicalmente lo stile del bluesman afroamericano. If There’s A God è un’ulteriore profonda critica nei confronti degli Stati Uniti, mentre Dreamer ci riporta nuovamente oltre il confine, in terra messicana. Simple Tools e No Hard Feelings sono ancora una volta due ballate che conquistano grazie alla loro suggestiva melodia e al sinuoso andamento.
Alla soglia dei 65 anni Ry Cooder non finisce di stupire. Dopo una straordinaria carriera contraddistinta dalla ricerca etno-musicologica, il chitarrista decide di scrivere canzoni vere, canzoni per la gente. Pull Up Some Dust And Sit Down, da un modo di dire degli anni Trenta, è una sorta di invito alla conversazione, a fermarsi a pensare. Ed è proprio a quegli anni che il nostro ha rivolto lo sguardo, agli anni della Grande Depressione, anni di lotta, sofferenza e disillusione. Tematiche purtroppo ancora attuali, in una società nella quale il gap tra ricchi e poveri si va ulteriormente allargando. I tempi sono difficili e Cooder ha deciso di far sentire la propria voce, come Woody Guthrie, Pete Seeger e molti altri avevano fatto prima di lui. Per farlo chiama a se, oltre al figlio Joachim, alcuni vecchi e fidati pards, come l’immortale Flaco Jimenez, Terry Evans, Willie Green, Arnold McCuller e Jim Keltner, approntando un disco di protesta forte e vigoroso, tra folk, blues e musica messicana, composto da 14 canzoni che sono altrettante urla di rabbia e dolore. Un esempio è la feroce Quicksand, già pubblicata prima dell’uscita del disco su I-Tunes, che si scaglia contro le repressive leggi anti immigrazione dello stato dell’Arizona, e i cui proventi verranno destinati al MALDEF (acronimo di Mexican American Legal Defense And Education Fund) che cerca di proteggere i diritti degli immigrati messicani. Alla marcia di stampo folk No Banker Left Behind spetta invece il compito di aprire l’album, e rievocando il titolo di un articolo apparso sul settimanale Truthdig, se la prende con le banche e lo strozzinaggio legalizzato, veri e propri cancri dell’economia mondiale. El corrido de Jesse James è puro mexican style, un armonioso valzer dove la protagonista indiscussa è la fisarmonica di Jimenez, ben sostenuta dai fiati della 10 Banda. Atmosfere messicane che pervadono anche l’incalzante Christmas Time This Year, che attinge dalla più pura tradizione nortena. Dirty Chateau e Baby Joined The Army sono due toccanti ed intense ballate; nella prima fanno la loro comparsa anche dei violini, mentre nella seconda troviamo il nostro impegnato a destreggiarsi in solitario con la propria chitarra. Humpty Dumpty World pare uscita da uno dei suoi primi lavori, riprendendo quegli stilemi sonori che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Lord Tell Me Why è una sorta di gospel post apocalittico, con la batteria di Jim Keltner a dettare il ritmo e con un sapiente uso del call and response grazie anche all’apporto delle voci di Terry Evans, Arnold McCuller e Willie Green. Waitisiana per sonorità e interpretazione è invece la rabbiosa e convulsa I Want My Crown, con il nostro quasi diabolico alla voce. Entriamo in territorio blues con John Lee Hooker For President, dove Cooder ci narra cosa sarebbe potuto accadere se John Lee Hooker fosse diventato presidente degli Stati Uniti, riprendendo musicalmente lo stile del bluesman afroamericano. If There’s A God è un’ulteriore profonda critica nei confronti degli Stati Uniti, mentre Dreamer ci riporta nuovamente oltre il confine, in terra messicana. Simple Tools e No Hard Feelings sono ancora una volta due ballate che conquistano grazie alla loro suggestiva melodia e al sinuoso andamento.
 Alla soglia dei 65 anni Ry Cooder non finisce di stupire. Dopo una straordinaria carriera contraddistinta dalla ricerca etno-musicologica, il chitarrista decide di scrivere canzoni vere, canzoni per la gente. Pull Up Some Dust And Sit Down, da un modo di dire degli anni Trenta, è una sorta di invito alla conversazione, a fermarsi a pensare. Ed è proprio a quegli anni che il nostro ha rivolto lo sguardo, agli anni della Grande Depressione, anni di lotta, sofferenza e disillusione. Tematiche purtroppo ancora attuali, in una società nella quale il gap tra ricchi e poveri si va ulteriormente allargando. I tempi sono difficili e Cooder ha deciso di far sentire la propria voce, come Woody Guthrie, Pete Seeger e molti altri avevano fatto prima di lui. Per farlo chiama a se, oltre al figlio Joachim, alcuni vecchi e fidati pards, come l’immortale Flaco Jimenez, Terry Evans, Willie Green, Arnold McCuller e Jim Keltner, approntando un disco di protesta forte e vigoroso, tra folk, blues e musica messicana, composto da 14 canzoni che sono altrettante urla di rabbia e dolore. Un esempio è la feroce Quicksand, già pubblicata prima dell’uscita del disco su I-Tunes, che si scaglia contro le repressive leggi anti immigrazione dello stato dell’Arizona, e i cui proventi verranno destinati al MALDEF (acronimo di Mexican American Legal Defense And Education Fund) che cerca di proteggere i diritti degli immigrati messicani. Alla marcia di stampo folk No Banker Left Behind spetta invece il compito di aprire l’album, e rievocando il titolo di un articolo apparso sul settimanale Truthdig, se la prende con le banche e lo strozzinaggio legalizzato, veri e propri cancri dell’economia mondiale. El corrido de Jesse James è puro mexican style, un armonioso valzer dove la protagonista indiscussa è la fisarmonica di Jimenez, ben sostenuta dai fiati della 10 Banda. Atmosfere messicane che pervadono anche l’incalzante Christmas Time This Year, che attinge dalla più pura tradizione nortena. Dirty Chateau e Baby Joined The Army sono due toccanti ed intense ballate; nella prima fanno la loro comparsa anche dei violini, mentre nella seconda troviamo il nostro impegnato a destreggiarsi in solitario con la propria chitarra. Humpty Dumpty World pare uscita da uno dei suoi primi lavori, riprendendo quegli stilemi sonori che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Lord Tell Me Why è una sorta di gospel post apocalittico, con la batteria di Jim Keltner a dettare il ritmo e con un sapiente uso del call and response grazie anche all’apporto delle voci di Terry Evans, Arnold McCuller e Willie Green. Waitisiana per sonorità e interpretazione è invece la rabbiosa e convulsa I Want My Crown, con il nostro quasi diabolico alla voce. Entriamo in territorio blues con John Lee Hooker For President, dove Cooder ci narra cosa sarebbe potuto accadere se John Lee Hooker fosse diventato presidente degli Stati Uniti, riprendendo musicalmente lo stile del bluesman afroamericano. If There’s A God è un’ulteriore profonda critica nei confronti degli Stati Uniti, mentre Dreamer ci riporta nuovamente oltre il confine, in terra messicana. Simple Tools e No Hard Feelings sono ancora una volta due ballate che conquistano grazie alla loro suggestiva melodia e al sinuoso andamento.
Alla soglia dei 65 anni Ry Cooder non finisce di stupire. Dopo una straordinaria carriera contraddistinta dalla ricerca etno-musicologica, il chitarrista decide di scrivere canzoni vere, canzoni per la gente. Pull Up Some Dust And Sit Down, da un modo di dire degli anni Trenta, è una sorta di invito alla conversazione, a fermarsi a pensare. Ed è proprio a quegli anni che il nostro ha rivolto lo sguardo, agli anni della Grande Depressione, anni di lotta, sofferenza e disillusione. Tematiche purtroppo ancora attuali, in una società nella quale il gap tra ricchi e poveri si va ulteriormente allargando. I tempi sono difficili e Cooder ha deciso di far sentire la propria voce, come Woody Guthrie, Pete Seeger e molti altri avevano fatto prima di lui. Per farlo chiama a se, oltre al figlio Joachim, alcuni vecchi e fidati pards, come l’immortale Flaco Jimenez, Terry Evans, Willie Green, Arnold McCuller e Jim Keltner, approntando un disco di protesta forte e vigoroso, tra folk, blues e musica messicana, composto da 14 canzoni che sono altrettante urla di rabbia e dolore. Un esempio è la feroce Quicksand, già pubblicata prima dell’uscita del disco su I-Tunes, che si scaglia contro le repressive leggi anti immigrazione dello stato dell’Arizona, e i cui proventi verranno destinati al MALDEF (acronimo di Mexican American Legal Defense And Education Fund) che cerca di proteggere i diritti degli immigrati messicani. Alla marcia di stampo folk No Banker Left Behind spetta invece il compito di aprire l’album, e rievocando il titolo di un articolo apparso sul settimanale Truthdig, se la prende con le banche e lo strozzinaggio legalizzato, veri e propri cancri dell’economia mondiale. El corrido de Jesse James è puro mexican style, un armonioso valzer dove la protagonista indiscussa è la fisarmonica di Jimenez, ben sostenuta dai fiati della 10 Banda. Atmosfere messicane che pervadono anche l’incalzante Christmas Time This Year, che attinge dalla più pura tradizione nortena. Dirty Chateau e Baby Joined The Army sono due toccanti ed intense ballate; nella prima fanno la loro comparsa anche dei violini, mentre nella seconda troviamo il nostro impegnato a destreggiarsi in solitario con la propria chitarra. Humpty Dumpty World pare uscita da uno dei suoi primi lavori, riprendendo quegli stilemi sonori che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Lord Tell Me Why è una sorta di gospel post apocalittico, con la batteria di Jim Keltner a dettare il ritmo e con un sapiente uso del call and response grazie anche all’apporto delle voci di Terry Evans, Arnold McCuller e Willie Green. Waitisiana per sonorità e interpretazione è invece la rabbiosa e convulsa I Want My Crown, con il nostro quasi diabolico alla voce. Entriamo in territorio blues con John Lee Hooker For President, dove Cooder ci narra cosa sarebbe potuto accadere se John Lee Hooker fosse diventato presidente degli Stati Uniti, riprendendo musicalmente lo stile del bluesman afroamericano. If There’s A God è un’ulteriore profonda critica nei confronti degli Stati Uniti, mentre Dreamer ci riporta nuovamente oltre il confine, in terra messicana. Simple Tools e No Hard Feelings sono ancora una volta due ballate che conquistano grazie alla loro suggestiva melodia e al sinuoso andamento.
Un album polemico, duro e politicizzato ma dalla bellezza adamantina. Un album coraggioso, scritto e suonato per far aprire gli occhi alla gente su di un mondo che sta scivolando verso un baratro senza ritorno.
Richmond Fontaine - The high country
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe accaduto se Willy Vlautin, leader incontrastato dei Richmond Fontaine, avesse deciso un giorno di fondere insieme le sue carriere di musicista e scrittore. Carriere nelle quali fino ad oggi il nostro ha brillato per estro creativo e capacità narrativa, descrivendo sia in musica che attraverso la propria penna l’America dei perdenti e dei derelitti, tanto da essere appellato dai più come il “Bob Dylan dei diseredati”.
Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe accaduto se Willy Vlautin, leader incontrastato dei Richmond Fontaine, avesse deciso un giorno di fondere insieme le sue carriere di musicista e scrittore. Carriere nelle quali fino ad oggi il nostro ha brillato per estro creativo e capacità narrativa, descrivendo sia in musica che attraverso la propria penna l’America dei perdenti e dei derelitti, tanto da essere appellato dai più come il “Bob Dylan dei diseredati”.
 Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe accaduto se Willy Vlautin, leader incontrastato dei Richmond Fontaine, avesse deciso un giorno di fondere insieme le sue carriere di musicista e scrittore. Carriere nelle quali fino ad oggi il nostro ha brillato per estro creativo e capacità narrativa, descrivendo sia in musica che attraverso la propria penna l’America dei perdenti e dei derelitti, tanto da essere appellato dai più come il “Bob Dylan dei diseredati”.
Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe accaduto se Willy Vlautin, leader incontrastato dei Richmond Fontaine, avesse deciso un giorno di fondere insieme le sue carriere di musicista e scrittore. Carriere nelle quali fino ad oggi il nostro ha brillato per estro creativo e capacità narrativa, descrivendo sia in musica che attraverso la propria penna l’America dei perdenti e dei derelitti, tanto da essere appellato dai più come il “Bob Dylan dei diseredati”.
Alla mia curiosità sembrava poter dare finalmente soddisfazione il nuovo The High Country, sorta di concept album con il desolato e sperduto Oregon come cornice, narrante la storia di un giovane meccanico innamorato di una ragazza commessa del locale negozio di ricambi d’auto. Mettiamo però subito le cose in chiaro, dicendo che chi, come il sottoscritto, si aspettava una fusione musico-narrativa tra Post To Wire e Motel Lfe rimarrà in parte deluso. Vlautin appronta infatti per l’occasione una novella in chiave gotica, tetra e scura, nella quale non riesce a far confluire in egual misura narrazione e musicalità, ed è forse questo uno dei limiti maggiori di The High Country. Se infatti le canzoni possono essere equiparate a capitoli di un ipotetico romanzo, sono gli intermezzi sonori spesso a deviare o disturbare l’ascolto. Basti prendere frammenti come The Girl On The Logging Road o The Mechanic Falls In Love With The Girl, che anziché legare tra di loro i vari episodi musicali hanno il difetto di rendere la fruizione alquanto tediosa. Per non parlare poi di veri e propri aborti semi-musicali come la quasi recitata Claude Murray’s Breakdown o Angus King Tries To Leave The House, davvero inutili e assolutamente evitabili.
Manca insomma un continuum narrativo tra la parte letteraria e quella musicale, che alla lunga penalizza la buona riuscita del disco, ed è un vero peccato in quanto la penna di Vlautin in alcuni frangenti resta comunque ispirata. Paradossalmente alcune canzoni trovano la loro ragione d’essere prese singolarmente e non quindi facenti capo a un’opera più ampia. Prendiamo per esempio l’epicità di The Chainsaw Sea o la furia quasi garage di Lost In The Trees, che riportano alla luce l’anima più elettrica della band oppure On A Spree dall’incedere quasi marziale e la ruvida The Escape. Azzeccata è invece la scelta di affidare le parti vocali maschili (il giovane meccanico della storia) allo stesso Vlautin, mentre quelle femminili (la commessa) a Deborah Kelly, ex Damnations. Proprio la voce di quest’ultima ha il pregio di attenuare in parte le atmosfere distorte dell’album, riconducendole versi lidi più acustici, come avviene nella tersa Let Me Dream Of The High Country o nella struggente The Meeting On The Logging Road.
Manca insomma un continuum narrativo tra la parte letteraria e quella musicale, che alla lunga penalizza la buona riuscita del disco, ed è un vero peccato in quanto la penna di Vlautin in alcuni frangenti resta comunque ispirata. Paradossalmente alcune canzoni trovano la loro ragione d’essere prese singolarmente e non quindi facenti capo a un’opera più ampia. Prendiamo per esempio l’epicità di The Chainsaw Sea o la furia quasi garage di Lost In The Trees, che riportano alla luce l’anima più elettrica della band oppure On A Spree dall’incedere quasi marziale e la ruvida The Escape. Azzeccata è invece la scelta di affidare le parti vocali maschili (il giovane meccanico della storia) allo stesso Vlautin, mentre quelle femminili (la commessa) a Deborah Kelly, ex Damnations. Proprio la voce di quest’ultima ha il pregio di attenuare in parte le atmosfere distorte dell’album, riconducendole versi lidi più acustici, come avviene nella tersa Let Me Dream Of The High Country o nella struggente The Meeting On The Logging Road.
Con The High Country, Vlautin ha cercato di creare il suo piccolo grande romanzo americano in musica riuscendovi tuttavia solo in parte, peccando forse di pretenziosità. Il talento indubbiamente c’è ma ha forse bisogno di essere ulteriormente affinato se in futuro vorrà nuovamente impegnarsi in opere così ambiziose.
giovedì 3 novembre 2011
Scott Matthew - Gallantry's favorite son
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Se il secondo disco è sempre quello più difficile nella carriera di un'artista (Caparezza docet), il terzo è altrettanto insidioso. Se con il secondo si deve infatti dimostrare di non essere un'effimera bolla di sapone, replicando spesso a un debutto incensato dalla critica come un piccolo capolavoro, è con il terzo album che si esprime spesso una raggiunta maturità artistica, nonchè una consolidata formula sonora. Ebbene, Scott Matthew con questo Gallantry's Favorite Son riesce egregiamente in entrambe le cose.Il cantautore australiano coniuga sapientemente un tenue indie-pop con la malinconia tipica del folk, in un album dove a prevalere sono i toni scuri e l'introspezione. Un disco nel quale sono gli strumenti a corde e le tastiere i veri protagonisti, mentre il lato prettamente ritmico è affidato a saltuari ma ben calibrati interventi di bizzarre percussioni, mai invasive e sempre al servizio della canzone. Le iniziali Black Bird e True Sting, sono ben esemplificative del lato più introspettivo del lavoro, con gli archi e le tastiere che si intrecciano tra loro, arricchendo la voce di Matthew, che riveste ruolo di vero e proprio strumento. Il nostro infatti ha approntato un impianto musicale parco e acustico, nel quale è spesso proprio la sua voce a risaltare per espressività diventando veicolo principale della sua musica. Apre ad atmosfere più solari, la giocosa Felicity, per fischiettii, violini, percussioni e chitarra, così come Devil's Only Child, dove fa la sua comparsa anche un clarinetto. Malinconica ballata è invece Duet, nella quale Matthew imbraccia il suo amato ukulele, che ben si amalgama con la chitarra acustica e con l'arpa, in un brano dall'alto tasso emotivo. Buried Alive è un acquerello acustico per sola chitarra e voce, con cori dall'afflato quasi gospel, così come Sinking per soli piano e ukulele, con un'interpretazione quasi sussurrata da parte del cantautore australiano. The Wonder Of Falling Life è sontuosa, a tratti quasi bacharachiana, segno di un ottimo lavoro sia in fase di composizione che di produzione, quest’ultima affidata all’esperto Mike Skinner. Sweet Kiss In The Afterlife ci mostra come, spesso, il togliere anzichè l'aggiungere può portare alla nascita di piccoli capolavori acustici. Seedling e Sweet Kiss In Afterlife tornano ad esplorare i meandri più profondi dell'animo di Matthew, che canta con sofferente trasporto. Chiude il disco la divertente, quasi doo wop No Place Called Hell, con ancora il fidato ukulele sugli scudi, accompagnato solamente da uno shaker, con azzeccati cori di sottofondo.
Un lavoro questo Gallantry's Favorite Son, non immediato, che necessita di un ascolto attento, ma che una volta dischiusosi saprà mostrarsi in tutta la sua cristallina purezza.
Se il secondo disco è sempre quello più difficile nella carriera di un'artista (Caparezza docet), il terzo è altrettanto insidioso. Se con il secondo si deve infatti dimostrare di non essere un'effimera bolla di sapone, replicando spesso a un debutto incensato dalla critica come un piccolo capolavoro, è con il terzo album che si esprime spesso una raggiunta maturità artistica, nonchè una consolidata formula sonora. Ebbene, Scott Matthew con questo Gallantry's Favorite Son riesce egregiamente in entrambe le cose.Il cantautore australiano coniuga sapientemente un tenue indie-pop con la malinconia tipica del folk, in un album dove a prevalere sono i toni scuri e l'introspezione. Un disco nel quale sono gli strumenti a corde e le tastiere i veri protagonisti, mentre il lato prettamente ritmico è affidato a saltuari ma ben calibrati interventi di bizzarre percussioni, mai invasive e sempre al servizio della canzone. Le iniziali Black Bird e True Sting, sono ben esemplificative del lato più introspettivo del lavoro, con gli archi e le tastiere che si intrecciano tra loro, arricchendo la voce di Matthew, che riveste ruolo di vero e proprio strumento. Il nostro infatti ha approntato un impianto musicale parco e acustico, nel quale è spesso proprio la sua voce a risaltare per espressività diventando veicolo principale della sua musica. Apre ad atmosfere più solari, la giocosa Felicity, per fischiettii, violini, percussioni e chitarra, così come Devil's Only Child, dove fa la sua comparsa anche un clarinetto. Malinconica ballata è invece Duet, nella quale Matthew imbraccia il suo amato ukulele, che ben si amalgama con la chitarra acustica e con l'arpa, in un brano dall'alto tasso emotivo. Buried Alive è un acquerello acustico per sola chitarra e voce, con cori dall'afflato quasi gospel, così come Sinking per soli piano e ukulele, con un'interpretazione quasi sussurrata da parte del cantautore australiano. The Wonder Of Falling Life è sontuosa, a tratti quasi bacharachiana, segno di un ottimo lavoro sia in fase di composizione che di produzione, quest’ultima affidata all’esperto Mike Skinner. Sweet Kiss In The Afterlife ci mostra come, spesso, il togliere anzichè l'aggiungere può portare alla nascita di piccoli capolavori acustici. Seedling e Sweet Kiss In Afterlife tornano ad esplorare i meandri più profondi dell'animo di Matthew, che canta con sofferente trasporto. Chiude il disco la divertente, quasi doo wop No Place Called Hell, con ancora il fidato ukulele sugli scudi, accompagnato solamente da uno shaker, con azzeccati cori di sottofondo.
Un lavoro questo Gallantry's Favorite Son, non immediato, che necessita di un ascolto attento, ma che una volta dischiusosi saprà mostrarsi in tutta la sua cristallina purezza.
 Se il secondo disco è sempre quello più difficile nella carriera di un'artista (Caparezza docet), il terzo è altrettanto insidioso. Se con il secondo si deve infatti dimostrare di non essere un'effimera bolla di sapone, replicando spesso a un debutto incensato dalla critica come un piccolo capolavoro, è con il terzo album che si esprime spesso una raggiunta maturità artistica, nonchè una consolidata formula sonora. Ebbene, Scott Matthew con questo Gallantry's Favorite Son riesce egregiamente in entrambe le cose.Il cantautore australiano coniuga sapientemente un tenue indie-pop con la malinconia tipica del folk, in un album dove a prevalere sono i toni scuri e l'introspezione. Un disco nel quale sono gli strumenti a corde e le tastiere i veri protagonisti, mentre il lato prettamente ritmico è affidato a saltuari ma ben calibrati interventi di bizzarre percussioni, mai invasive e sempre al servizio della canzone. Le iniziali Black Bird e True Sting, sono ben esemplificative del lato più introspettivo del lavoro, con gli archi e le tastiere che si intrecciano tra loro, arricchendo la voce di Matthew, che riveste ruolo di vero e proprio strumento. Il nostro infatti ha approntato un impianto musicale parco e acustico, nel quale è spesso proprio la sua voce a risaltare per espressività diventando veicolo principale della sua musica. Apre ad atmosfere più solari, la giocosa Felicity, per fischiettii, violini, percussioni e chitarra, così come Devil's Only Child, dove fa la sua comparsa anche un clarinetto. Malinconica ballata è invece Duet, nella quale Matthew imbraccia il suo amato ukulele, che ben si amalgama con la chitarra acustica e con l'arpa, in un brano dall'alto tasso emotivo. Buried Alive è un acquerello acustico per sola chitarra e voce, con cori dall'afflato quasi gospel, così come Sinking per soli piano e ukulele, con un'interpretazione quasi sussurrata da parte del cantautore australiano. The Wonder Of Falling Life è sontuosa, a tratti quasi bacharachiana, segno di un ottimo lavoro sia in fase di composizione che di produzione, quest’ultima affidata all’esperto Mike Skinner. Sweet Kiss In The Afterlife ci mostra come, spesso, il togliere anzichè l'aggiungere può portare alla nascita di piccoli capolavori acustici. Seedling e Sweet Kiss In Afterlife tornano ad esplorare i meandri più profondi dell'animo di Matthew, che canta con sofferente trasporto. Chiude il disco la divertente, quasi doo wop No Place Called Hell, con ancora il fidato ukulele sugli scudi, accompagnato solamente da uno shaker, con azzeccati cori di sottofondo.
Se il secondo disco è sempre quello più difficile nella carriera di un'artista (Caparezza docet), il terzo è altrettanto insidioso. Se con il secondo si deve infatti dimostrare di non essere un'effimera bolla di sapone, replicando spesso a un debutto incensato dalla critica come un piccolo capolavoro, è con il terzo album che si esprime spesso una raggiunta maturità artistica, nonchè una consolidata formula sonora. Ebbene, Scott Matthew con questo Gallantry's Favorite Son riesce egregiamente in entrambe le cose.Il cantautore australiano coniuga sapientemente un tenue indie-pop con la malinconia tipica del folk, in un album dove a prevalere sono i toni scuri e l'introspezione. Un disco nel quale sono gli strumenti a corde e le tastiere i veri protagonisti, mentre il lato prettamente ritmico è affidato a saltuari ma ben calibrati interventi di bizzarre percussioni, mai invasive e sempre al servizio della canzone. Le iniziali Black Bird e True Sting, sono ben esemplificative del lato più introspettivo del lavoro, con gli archi e le tastiere che si intrecciano tra loro, arricchendo la voce di Matthew, che riveste ruolo di vero e proprio strumento. Il nostro infatti ha approntato un impianto musicale parco e acustico, nel quale è spesso proprio la sua voce a risaltare per espressività diventando veicolo principale della sua musica. Apre ad atmosfere più solari, la giocosa Felicity, per fischiettii, violini, percussioni e chitarra, così come Devil's Only Child, dove fa la sua comparsa anche un clarinetto. Malinconica ballata è invece Duet, nella quale Matthew imbraccia il suo amato ukulele, che ben si amalgama con la chitarra acustica e con l'arpa, in un brano dall'alto tasso emotivo. Buried Alive è un acquerello acustico per sola chitarra e voce, con cori dall'afflato quasi gospel, così come Sinking per soli piano e ukulele, con un'interpretazione quasi sussurrata da parte del cantautore australiano. The Wonder Of Falling Life è sontuosa, a tratti quasi bacharachiana, segno di un ottimo lavoro sia in fase di composizione che di produzione, quest’ultima affidata all’esperto Mike Skinner. Sweet Kiss In The Afterlife ci mostra come, spesso, il togliere anzichè l'aggiungere può portare alla nascita di piccoli capolavori acustici. Seedling e Sweet Kiss In Afterlife tornano ad esplorare i meandri più profondi dell'animo di Matthew, che canta con sofferente trasporto. Chiude il disco la divertente, quasi doo wop No Place Called Hell, con ancora il fidato ukulele sugli scudi, accompagnato solamente da uno shaker, con azzeccati cori di sottofondo. Dogs in a flat - Days before the robbery
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Arrivano dal Veneto i Dogs In A Flat, ma hanno orecchie e occhi rivolti al di la dell’Oceano, nei meandri più oscuri e profondi dell’America. Days Before The Robbery preleva infatti a piene mani dalla musica a stelle e strisce, sia per quanto riguarda la parte strettamente musicale, sia a livello testuale. I nostri hanno approntato una formula sonora che trova nel country tinto di rock, con alcune suggestive derive alternative, il suo marchio di fabbrica.
Arrivano dal Veneto i Dogs In A Flat, ma hanno orecchie e occhi rivolti al di la dell’Oceano, nei meandri più oscuri e profondi dell’America. Days Before The Robbery preleva infatti a piene mani dalla musica a stelle e strisce, sia per quanto riguarda la parte strettamente musicale, sia a livello testuale. I nostri hanno approntato una formula sonora che trova nel country tinto di rock, con alcune suggestive derive alternative, il suo marchio di fabbrica.
Americanità che si riflette anche nelle liriche, che recuperano tematiche tanto care a questo genere di musica, a partire dal titolo, alquanto esplicativo: Days Before The Robbery, (i giorni prima della rapina). Non si tratta però di una sorta di concept album, in quanto solo gli ultimi due brani narrano i momenti prossimi al misfatto, ma bensì di una riflessione su di un sogno troppe volte disilluso, quello americano, attraverso le tristi storie di quelli che comunemente vengono additati come losers. Prendiamo per esempio l’opener Peggy’s Night, storia di una lap dancer che non vede l’ora di tornare dal proprio figlio, dove emerge l’anima rock a tinte scure della band, con la voce loureediana di Michele Scarpulla in primo piano. Atmosfere tenui invece per Diamond Age, struggente ballata tutta giocata sull’alternanza tra voci maschili e femminili, con gli splendidi interventi del violino di Federica Capra a suggellare il tutto. Old Dirt Road è puro alternative country, avvolgente e sinuosa ti cattura fin dal primo ascolto, grazie anche a un ottimo lavoro delle chitarre e del violino ben coadiuvati da una sezione ritmica impeccabile, affidata alle mani esperte del bassista Patrizio Pellizzon e della batterista Lisa Cappellazzo.
Attinge dalla tradizione americana il quasi valzer Houses, che dimostra una volta di più come il gruppo sappia destreggiarsi egregiamente con questo tipo di sonorità. Sam Radio Star ci riporta nuovamente verso atmosfere più soffuse, narrando la vita di Sam, dj radiofonico che parla ad un mondo annoiato e demotivato. Convulsa nel suo incedere è Steel Horse, sorta di talking country, tra pause e ripartenze, mentre nell’epica Raised On Radio il connubio tra chitarre e violino raggiunge picchi artistici elevatissimi. Broken Bones è dannatamente country, e non sfigurerebbe nei palinsesti delle radio di Nashville e dintorni. Chiudono l’album Neither Up Nor Down e Shine, descrivendo gli istanti prima della rapina, tra atmosfere country & western e sferzate rock.
I Dogs In A Flat riescono quindi nel non facile intento di far loro un’estetica musicale tipicamente americana, rinvigorendola con robuste dosi di indie rock. Days Before The Robbery è un album che saprà stregarvi fin dal primo ascolto, catapultandovi in un mondo lontano e sperduto tra derelitti e delinquenti.
 Arrivano dal Veneto i Dogs In A Flat, ma hanno orecchie e occhi rivolti al di la dell’Oceano, nei meandri più oscuri e profondi dell’America. Days Before The Robbery preleva infatti a piene mani dalla musica a stelle e strisce, sia per quanto riguarda la parte strettamente musicale, sia a livello testuale. I nostri hanno approntato una formula sonora che trova nel country tinto di rock, con alcune suggestive derive alternative, il suo marchio di fabbrica.
Arrivano dal Veneto i Dogs In A Flat, ma hanno orecchie e occhi rivolti al di la dell’Oceano, nei meandri più oscuri e profondi dell’America. Days Before The Robbery preleva infatti a piene mani dalla musica a stelle e strisce, sia per quanto riguarda la parte strettamente musicale, sia a livello testuale. I nostri hanno approntato una formula sonora che trova nel country tinto di rock, con alcune suggestive derive alternative, il suo marchio di fabbrica. Americanità che si riflette anche nelle liriche, che recuperano tematiche tanto care a questo genere di musica, a partire dal titolo, alquanto esplicativo: Days Before The Robbery, (i giorni prima della rapina). Non si tratta però di una sorta di concept album, in quanto solo gli ultimi due brani narrano i momenti prossimi al misfatto, ma bensì di una riflessione su di un sogno troppe volte disilluso, quello americano, attraverso le tristi storie di quelli che comunemente vengono additati come losers. Prendiamo per esempio l’opener Peggy’s Night, storia di una lap dancer che non vede l’ora di tornare dal proprio figlio, dove emerge l’anima rock a tinte scure della band, con la voce loureediana di Michele Scarpulla in primo piano. Atmosfere tenui invece per Diamond Age, struggente ballata tutta giocata sull’alternanza tra voci maschili e femminili, con gli splendidi interventi del violino di Federica Capra a suggellare il tutto. Old Dirt Road è puro alternative country, avvolgente e sinuosa ti cattura fin dal primo ascolto, grazie anche a un ottimo lavoro delle chitarre e del violino ben coadiuvati da una sezione ritmica impeccabile, affidata alle mani esperte del bassista Patrizio Pellizzon e della batterista Lisa Cappellazzo.
Attinge dalla tradizione americana il quasi valzer Houses, che dimostra una volta di più come il gruppo sappia destreggiarsi egregiamente con questo tipo di sonorità. Sam Radio Star ci riporta nuovamente verso atmosfere più soffuse, narrando la vita di Sam, dj radiofonico che parla ad un mondo annoiato e demotivato. Convulsa nel suo incedere è Steel Horse, sorta di talking country, tra pause e ripartenze, mentre nell’epica Raised On Radio il connubio tra chitarre e violino raggiunge picchi artistici elevatissimi. Broken Bones è dannatamente country, e non sfigurerebbe nei palinsesti delle radio di Nashville e dintorni. Chiudono l’album Neither Up Nor Down e Shine, descrivendo gli istanti prima della rapina, tra atmosfere country & western e sferzate rock.
I Dogs In A Flat riescono quindi nel non facile intento di far loro un’estetica musicale tipicamente americana, rinvigorendola con robuste dosi di indie rock. Days Before The Robbery è un album che saprà stregarvi fin dal primo ascolto, catapultandovi in un mondo lontano e sperduto tra derelitti e delinquenti.
Marco Notari - IO?
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 Cantautore in bilico tra introspezione e creatività dirompente, questo è Marco Notari. Il musicista torinese, dopo gli ottimi successi di critica e pubblico dei precedenti lavori, Oltre Lo Specchio e il concept , torna nuovamente ad incantare con Io?. Un disco coraggioso, nel quale il nostro mette a nudo i propri sentimenti e la propria anima attraverso dieci canzoni estatiche dalla musicalità avvolgente. Musicalità nella quale confluiscono contributi di strumenti di matrice tipicamente rock come chitarra, pianoforte e basso, insieme a quelli di archi, ottoni, strumenti a fiato, glockenspiel, il tutto condito da una lieve spruzzata di elettronica, e con una sezione ritmica che alterna, in alcuni frangenti, alla più canonica batteria un vero e proprio set da banda, oltre all’apporto percussivo di alcune scatole di cartone.
Cantautore in bilico tra introspezione e creatività dirompente, questo è Marco Notari. Il musicista torinese, dopo gli ottimi successi di critica e pubblico dei precedenti lavori, Oltre Lo Specchio e il concept , torna nuovamente ad incantare con Io?. Un disco coraggioso, nel quale il nostro mette a nudo i propri sentimenti e la propria anima attraverso dieci canzoni estatiche dalla musicalità avvolgente. Musicalità nella quale confluiscono contributi di strumenti di matrice tipicamente rock come chitarra, pianoforte e basso, insieme a quelli di archi, ottoni, strumenti a fiato, glockenspiel, il tutto condito da una lieve spruzzata di elettronica, e con una sezione ritmica che alterna, in alcuni frangenti, alla più canonica batteria un vero e proprio set da banda, oltre all’apporto percussivo di alcune scatole di cartone.
Un album variegato quindi, capace di abbracciare diversi generi musicali; dal folk, al pop fino all’elettronica, per sfociare in territori quasi ambient, rielaborandoli in una formula sonora maestosa quanto affascinante, alla quale fa da contraltare una capacità di scrittura ormai matura e consolidata. Sono proprio i testi infatti, ricercati e mai banali, l’arma vincente di Io?.
Testi che narrano tematiche differenti, partendo da introspettivi elementi autobiografici, per poi allargare la visione all’intera umanità, descrivendone le contraddizioni. Elementi autobiografici che troviamo in brani come la title track e Io, Il Mio Corpo E l’Inconscio. La prima è una sorta di acquisizione, in musica, della consapevolezza del trascorrere inesorabile del tempo, attraverso un viaggio mentale nel passato, fino al momento della propria nascita. In odore di indie pop, Io, Il Mio Corpo e l’Inconscio, rappresenta idealmente l’urgenza di fissare su di un supporto fisico, in questo caso un disco, storie di persone e cose che per loro natura hanno un principio e una fine. Deliziosa è Le Stelle Ci Cambieranno Pelle, tra sogni e speranze per il futuro, con ospite Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione alla voce, nonché autore del caleidoscopico artwork dell’album.
Di tono decisamente diverso è la tetra e dura La Terra Senza L’Uomo, nella quale viene messa in luce la vera piaga di un mondo ormai al declino, l’uomo appunto, senza il quale il pianeta sarebbe un posto migliore. Lieve come il vento primaverile è invece Dina, struggente dedica alla propria nonna recentemente scomparsa. Hamsik corre sui binari della modernità e prendendo spunto dall’eliminazione della Nazione Italiana di calcio dai Mondiali, ad opera della nazionale Slovacca capitanata proprio dal giocatore del Napoli, paragona la sconfitta dell’Italia calcistica a quella dell’Italia politica. Intrisa di sofferenza è L’Invasione Degli Ultracorpi, con ospite alla voce Dario Brunori, che attraverso le storie di Davide e Mohammed, due uomini che osservano il medesimo cielo seppur da luoghi distanti fra loro, ci fa capire come spesso i media riescano a creare diversità inesistenti. La malinconica Apollo 11 e l’onirica Canzone d’Amore e d’Anarchia, omaggio musicale al cinema di Lina Wertmuller, si mantengono sempre su livelli altissimi, mentre spetta al reprise strumentale di Io? chiudere degnamente l’album.
Un lavoro nel quale emerge, fin dalla copertina, una cura maniacale per i dettagli, sia per quanto riguarda gli arrangiamenti sia a livello testuale. Un plauso va quindi a Marco Notari, per essere nuovamente riuscito a creare una formula sonora tanto accattivante quanto personale.
 Cantautore in bilico tra introspezione e creatività dirompente, questo è Marco Notari. Il musicista torinese, dopo gli ottimi successi di critica e pubblico dei precedenti lavori, Oltre Lo Specchio e il concept , torna nuovamente ad incantare con Io?. Un disco coraggioso, nel quale il nostro mette a nudo i propri sentimenti e la propria anima attraverso dieci canzoni estatiche dalla musicalità avvolgente. Musicalità nella quale confluiscono contributi di strumenti di matrice tipicamente rock come chitarra, pianoforte e basso, insieme a quelli di archi, ottoni, strumenti a fiato, glockenspiel, il tutto condito da una lieve spruzzata di elettronica, e con una sezione ritmica che alterna, in alcuni frangenti, alla più canonica batteria un vero e proprio set da banda, oltre all’apporto percussivo di alcune scatole di cartone.
Cantautore in bilico tra introspezione e creatività dirompente, questo è Marco Notari. Il musicista torinese, dopo gli ottimi successi di critica e pubblico dei precedenti lavori, Oltre Lo Specchio e il concept , torna nuovamente ad incantare con Io?. Un disco coraggioso, nel quale il nostro mette a nudo i propri sentimenti e la propria anima attraverso dieci canzoni estatiche dalla musicalità avvolgente. Musicalità nella quale confluiscono contributi di strumenti di matrice tipicamente rock come chitarra, pianoforte e basso, insieme a quelli di archi, ottoni, strumenti a fiato, glockenspiel, il tutto condito da una lieve spruzzata di elettronica, e con una sezione ritmica che alterna, in alcuni frangenti, alla più canonica batteria un vero e proprio set da banda, oltre all’apporto percussivo di alcune scatole di cartone. Un album variegato quindi, capace di abbracciare diversi generi musicali; dal folk, al pop fino all’elettronica, per sfociare in territori quasi ambient, rielaborandoli in una formula sonora maestosa quanto affascinante, alla quale fa da contraltare una capacità di scrittura ormai matura e consolidata. Sono proprio i testi infatti, ricercati e mai banali, l’arma vincente di Io?.
Testi che narrano tematiche differenti, partendo da introspettivi elementi autobiografici, per poi allargare la visione all’intera umanità, descrivendone le contraddizioni. Elementi autobiografici che troviamo in brani come la title track e Io, Il Mio Corpo E l’Inconscio. La prima è una sorta di acquisizione, in musica, della consapevolezza del trascorrere inesorabile del tempo, attraverso un viaggio mentale nel passato, fino al momento della propria nascita. In odore di indie pop, Io, Il Mio Corpo e l’Inconscio, rappresenta idealmente l’urgenza di fissare su di un supporto fisico, in questo caso un disco, storie di persone e cose che per loro natura hanno un principio e una fine. Deliziosa è Le Stelle Ci Cambieranno Pelle, tra sogni e speranze per il futuro, con ospite Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione alla voce, nonché autore del caleidoscopico artwork dell’album.
Di tono decisamente diverso è la tetra e dura La Terra Senza L’Uomo, nella quale viene messa in luce la vera piaga di un mondo ormai al declino, l’uomo appunto, senza il quale il pianeta sarebbe un posto migliore. Lieve come il vento primaverile è invece Dina, struggente dedica alla propria nonna recentemente scomparsa. Hamsik corre sui binari della modernità e prendendo spunto dall’eliminazione della Nazione Italiana di calcio dai Mondiali, ad opera della nazionale Slovacca capitanata proprio dal giocatore del Napoli, paragona la sconfitta dell’Italia calcistica a quella dell’Italia politica. Intrisa di sofferenza è L’Invasione Degli Ultracorpi, con ospite alla voce Dario Brunori, che attraverso le storie di Davide e Mohammed, due uomini che osservano il medesimo cielo seppur da luoghi distanti fra loro, ci fa capire come spesso i media riescano a creare diversità inesistenti. La malinconica Apollo 11 e l’onirica Canzone d’Amore e d’Anarchia, omaggio musicale al cinema di Lina Wertmuller, si mantengono sempre su livelli altissimi, mentre spetta al reprise strumentale di Io? chiudere degnamente l’album.
Un lavoro nel quale emerge, fin dalla copertina, una cura maniacale per i dettagli, sia per quanto riguarda gli arrangiamenti sia a livello testuale. Un plauso va quindi a Marco Notari, per essere nuovamente riuscito a creare una formula sonora tanto accattivante quanto personale.
Felice Brothers - Celebration, Florida
(Pubblicato su Extra! Music Magazine)
 L'attesa per il nuovo album dei Felice Brothers era spasmodica. Come avrebbero reagito i nostri all'abbandono di Simone Felice? Questa era una delle domande che si poneva più di un addetto ai lavori, anche alla luce dell'ottimo progetto messo in piedi proprio dall'ex batterista, quel The Duke And The King che ha riscosso più di un giudizio favorevole. E se la vena creativa della band si fosse affievolita se non addirittura esaurita? Notizia confortante era stata senza ombra di dubbio quella del passaggio dei nostri alla Fat Possum, che aveva però contribuito ad aumentare ancora di più la curiosità generale.
L'attesa per il nuovo album dei Felice Brothers era spasmodica. Come avrebbero reagito i nostri all'abbandono di Simone Felice? Questa era una delle domande che si poneva più di un addetto ai lavori, anche alla luce dell'ottimo progetto messo in piedi proprio dall'ex batterista, quel The Duke And The King che ha riscosso più di un giudizio favorevole. E se la vena creativa della band si fosse affievolita se non addirittura esaurita? Notizia confortante era stata senza ombra di dubbio quella del passaggio dei nostri alla Fat Possum, che aveva però contribuito ad aumentare ancora di più la curiosità generale.
 L'attesa per il nuovo album dei Felice Brothers era spasmodica. Come avrebbero reagito i nostri all'abbandono di Simone Felice? Questa era una delle domande che si poneva più di un addetto ai lavori, anche alla luce dell'ottimo progetto messo in piedi proprio dall'ex batterista, quel The Duke And The King che ha riscosso più di un giudizio favorevole. E se la vena creativa della band si fosse affievolita se non addirittura esaurita? Notizia confortante era stata senza ombra di dubbio quella del passaggio dei nostri alla Fat Possum, che aveva però contribuito ad aumentare ancora di più la curiosità generale.
L'attesa per il nuovo album dei Felice Brothers era spasmodica. Come avrebbero reagito i nostri all'abbandono di Simone Felice? Questa era una delle domande che si poneva più di un addetto ai lavori, anche alla luce dell'ottimo progetto messo in piedi proprio dall'ex batterista, quel The Duke And The King che ha riscosso più di un giudizio favorevole. E se la vena creativa della band si fosse affievolita se non addirittura esaurita? Notizia confortante era stata senza ombra di dubbio quella del passaggio dei nostri alla Fat Possum, che aveva però contribuito ad aumentare ancora di più la curiosità generale.
Infine dopo due anni di gestazione ecco finalmente fare la sua comparsa Celebration, Florida, in grado di spazzare via ogni dubbio sul futuro della band. Registrato a New York, tra una palestra e il Beacon Theatre, il nuovo lavoro sembra riprendere le atmosfere e le scelte stilistiche che erano alla base di Yonder Is The Clock. Ampliando l'indie folk in odore di Americana degli esordi infatti, la band ha saputo creare un’esilarante amalgama tra una deviata sezione fiati, inaspettate reminescenze 80s, linee di synth di matrice quasi ambient, una batteria tribale, linee di basso marcatamente heavy, una fisarmonica e un piano schizofrenici; in grado di catturare e coinvolgere l’ascoltatore in un vortice sonoro irresistibile.
Si prenda l'opener Fire At The Pageant, una sorta di macabro talking sopra un folle impianto strumentale, dove su di un ritmo infernale irrompe un coro sguaiato. Ed è proprio questa fusione tra antico e moderno a caratterizzare quasi tutto il lavoro. Ritmi rallentati invece in Container Ship, dove al piano si unisce un beatbox dalla grana grossa. La fisarmonica di James Felice torna in primo piano nella successiva Honda Civic, che parte in sordina per poi sfociare in un'orgia di fiati. Esplicativo della trasformazione sonora dei Felice Brothers è Ponzi, non a caso scelto come singolo, che trasuda modernismo da ogni nota pur rimanendo ancorato in parte al suono familiare della band; così come Refrain, dove il ricorso all’elettronica si fa ancora più marcato. Cus’s Catskill Gym si regge su un apocalittico riff di chitarra, che ricorda da vicino quanto fatto dagli ultimi Raconteurs, alternando sferzate elettriche ad intermezzi acustici. Best I Ever Had e Dallas ci riportano invece all'omonimo esordio della band, terse ballate acustiche nelle quali la voce dylaniana di Ian si erge ad unica e incontrastata protagonista. La lunga e rarefatta River Jordan è a mio avviso uno dei migliori episodi del lotto, con un liquido Hammond a colorare il tutto. Ian e James dimostrano pertanto di non aver abbandonato la strada tracciata dai lavori precedenti, ma anzi, grazie ad un songwriting che sfiora in alcuni casi l’eccellenza, hanno aperto nuovi e suggestivi sentieri, ancora tutti da esplorare.
Un disco forse non immediato questo Celebration, Florida, ma se avete amato i precedenti dischi dei fratelli Felice, ne rimarrete ammaliati ascolto dopo ascolto.Si prenda l'opener Fire At The Pageant, una sorta di macabro talking sopra un folle impianto strumentale, dove su di un ritmo infernale irrompe un coro sguaiato. Ed è proprio questa fusione tra antico e moderno a caratterizzare quasi tutto il lavoro. Ritmi rallentati invece in Container Ship, dove al piano si unisce un beatbox dalla grana grossa. La fisarmonica di James Felice torna in primo piano nella successiva Honda Civic, che parte in sordina per poi sfociare in un'orgia di fiati. Esplicativo della trasformazione sonora dei Felice Brothers è Ponzi, non a caso scelto come singolo, che trasuda modernismo da ogni nota pur rimanendo ancorato in parte al suono familiare della band; così come Refrain, dove il ricorso all’elettronica si fa ancora più marcato. Cus’s Catskill Gym si regge su un apocalittico riff di chitarra, che ricorda da vicino quanto fatto dagli ultimi Raconteurs, alternando sferzate elettriche ad intermezzi acustici. Best I Ever Had e Dallas ci riportano invece all'omonimo esordio della band, terse ballate acustiche nelle quali la voce dylaniana di Ian si erge ad unica e incontrastata protagonista. La lunga e rarefatta River Jordan è a mio avviso uno dei migliori episodi del lotto, con un liquido Hammond a colorare il tutto. Ian e James dimostrano pertanto di non aver abbandonato la strada tracciata dai lavori precedenti, ma anzi, grazie ad un songwriting che sfiora in alcuni casi l’eccellenza, hanno aperto nuovi e suggestivi sentieri, ancora tutti da esplorare.
Mark "Pocket" Goldberg - Off the alleway
(Pubblicato su Rootshighway)
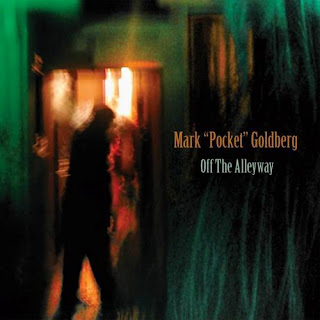 Lungo i polverosi sentieri del blues ci si può imbattere nei più disparati personaggi; uomini e donne con la musica nell'anima; fieri testimoni di una tradizione musicale antica e ricca di fascino, in grado ancora oggi di fare proseliti. Ed è proprio su uno di questi sentieri che incrociamo Mark "Pocket" Goldberg. Contrabbassista di vaglia, il nostro arriva con questo Off the Alleyway al suo debutto solista. Un lavoro composto da dodici brani originali: scelta coraggiosa che mette in luce le ottime capacità di scrittura del nostro. Goldberg si circonda di un terzetto di musicisti di valore, composto da Debra Dobkin alla batteria, percussioni e voce, Nick Kirgo alle chitarre e David Fraser al piano, accordion e armonica, ai quali si aggiungono alcuni ospiti del calibro di Terry Evans, Jay Dee Madness e James Gadson. Quello che colpisce fin dal primo ascolto è però la voce di Goldberg, descritta come l'incontro tra Howlin Wolf, Johnny Cash, Randy Newman e Leonard Cohen all'annuale Bar-B-Que Picnic organizzato da Louis Armstrong. Un'immagine suggestiva che rende appieno l'idea della vocalità del nostro: roca, quasi demoniaca in alcuni momenti, baritonale in altri.
Lungo i polverosi sentieri del blues ci si può imbattere nei più disparati personaggi; uomini e donne con la musica nell'anima; fieri testimoni di una tradizione musicale antica e ricca di fascino, in grado ancora oggi di fare proseliti. Ed è proprio su uno di questi sentieri che incrociamo Mark "Pocket" Goldberg. Contrabbassista di vaglia, il nostro arriva con questo Off the Alleyway al suo debutto solista. Un lavoro composto da dodici brani originali: scelta coraggiosa che mette in luce le ottime capacità di scrittura del nostro. Goldberg si circonda di un terzetto di musicisti di valore, composto da Debra Dobkin alla batteria, percussioni e voce, Nick Kirgo alle chitarre e David Fraser al piano, accordion e armonica, ai quali si aggiungono alcuni ospiti del calibro di Terry Evans, Jay Dee Madness e James Gadson. Quello che colpisce fin dal primo ascolto è però la voce di Goldberg, descritta come l'incontro tra Howlin Wolf, Johnny Cash, Randy Newman e Leonard Cohen all'annuale Bar-B-Que Picnic organizzato da Louis Armstrong. Un'immagine suggestiva che rende appieno l'idea della vocalità del nostro: roca, quasi demoniaca in alcuni momenti, baritonale in altri.
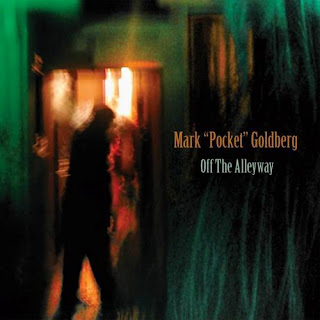 Lungo i polverosi sentieri del blues ci si può imbattere nei più disparati personaggi; uomini e donne con la musica nell'anima; fieri testimoni di una tradizione musicale antica e ricca di fascino, in grado ancora oggi di fare proseliti. Ed è proprio su uno di questi sentieri che incrociamo Mark "Pocket" Goldberg. Contrabbassista di vaglia, il nostro arriva con questo Off the Alleyway al suo debutto solista. Un lavoro composto da dodici brani originali: scelta coraggiosa che mette in luce le ottime capacità di scrittura del nostro. Goldberg si circonda di un terzetto di musicisti di valore, composto da Debra Dobkin alla batteria, percussioni e voce, Nick Kirgo alle chitarre e David Fraser al piano, accordion e armonica, ai quali si aggiungono alcuni ospiti del calibro di Terry Evans, Jay Dee Madness e James Gadson. Quello che colpisce fin dal primo ascolto è però la voce di Goldberg, descritta come l'incontro tra Howlin Wolf, Johnny Cash, Randy Newman e Leonard Cohen all'annuale Bar-B-Que Picnic organizzato da Louis Armstrong. Un'immagine suggestiva che rende appieno l'idea della vocalità del nostro: roca, quasi demoniaca in alcuni momenti, baritonale in altri.
Lungo i polverosi sentieri del blues ci si può imbattere nei più disparati personaggi; uomini e donne con la musica nell'anima; fieri testimoni di una tradizione musicale antica e ricca di fascino, in grado ancora oggi di fare proseliti. Ed è proprio su uno di questi sentieri che incrociamo Mark "Pocket" Goldberg. Contrabbassista di vaglia, il nostro arriva con questo Off the Alleyway al suo debutto solista. Un lavoro composto da dodici brani originali: scelta coraggiosa che mette in luce le ottime capacità di scrittura del nostro. Goldberg si circonda di un terzetto di musicisti di valore, composto da Debra Dobkin alla batteria, percussioni e voce, Nick Kirgo alle chitarre e David Fraser al piano, accordion e armonica, ai quali si aggiungono alcuni ospiti del calibro di Terry Evans, Jay Dee Madness e James Gadson. Quello che colpisce fin dal primo ascolto è però la voce di Goldberg, descritta come l'incontro tra Howlin Wolf, Johnny Cash, Randy Newman e Leonard Cohen all'annuale Bar-B-Que Picnic organizzato da Louis Armstrong. Un'immagine suggestiva che rende appieno l'idea della vocalità del nostro: roca, quasi demoniaca in alcuni momenti, baritonale in altri.
Esempio perfetto di quanto detto poc'anzi è l'opener No mercy for the Wicked Blues, una sorta di incrocio tra gli ululati di Howlin Wolf e l'eclettismo vocale del Tom Waits più roots oriented; il tutto su di un impianto strumentale di matrice tipicamente blues, con Fraser a soffiare sapientemente nella sua armonica. In odore di border è invece Bumps in the Road, con l'accordion a dettare i ritmi ben supportato da un ottimo lavoro ritmico e da una chitarra slide che ricorda a tratti il miglior Ry Cooder. Intrisa di gospel è invece la struggente This Train, con una prestazione vocale di Goldberg di grande intensità a cui fanno da contraltare i cori ad opera di Teresa James e Billy Watts. Più prettamente blues sono invece lo shuffle Down Home Woman e lo slow Lost Another one Blues, dove in quest'ultima fanno la loro comparsa i Texicali Horns e Barry Goldberg all'hammond.
Di stampo pianistico sono le terse Walkin Away e Whistlin Away simili sia per titolo che per impostazione strumentale. She Carries sembra arrivare da un disco della Band, mid-tempo intriso di quel classico suono delle radici, del quale il gruppo di Levon Helm è stato uno dei massimi esponenti. Più country oriented è invece No Prison Bars, che vede la presenza alla pedal steel di Jay Dee Maness. Pedal steel che ritorna nuovamente nell'incalzante country'n'roll Best on My Way. Before You Go è un divertente doo wop, con i suoni vintage tipici degli anni '50. Quasi voodoo è invece la finale Bounce, tutta giocata sull'insolito abbinamento sezione ritmica-voci. Un disco di pregevole fattura questo Off the Alleyway, in grado di emozionare con il suo variegato patchwork musicale. Un consiglio? Procuratevelo!
Josh Harty - Nowhere
(Pubblicato su Rootshighway)
 Trentatrè anni, dal North Dakota, figlio di un capo della polizia e predicatore, insieme al quale inizia a cantare musica country e gospel: basterebbe solamente la storia personale di Josh Harty per ascriverlo al nutrito elenco dei tanti "beautiful losers" che affollano la musica americana. Musicisti e cantori che dagli spazi più angusti e nascosti dell'America rurale provano a far sentire la propria voce, il più delle volte cadendo preda dell'oblio, illusi e spesso sbeffeggiati da un mercato discografico sempre meno magnanimo e sempre più legato alla logica del profitto. Il ragazzo in questione ha però classe e stoffa da vendere, che traspirano da ogni solco di questo suo ultimo ep Nowhere. Un concentrato di tutti gli ingredienti alla base della musica americana, nella più pura accezione del termine; una riuscita miscela tra folk e country, che richiama paesaggi rurali e vita agreste, in una sorta di quadro bucolico in musica. Musica acustica, per palati fini, un pugno di canzoni che cattura e conquista fin dal primo ascolto, per semplicità e bellezza. Merito senza dubbio della penna ispirata del nostro e di una voce dalla liricità strabiliante, il tutto su di un impianto strumentale nel quale a regnare è la chitarra acustica sapientemente pizzicata dallo stesso Harty.
Trentatrè anni, dal North Dakota, figlio di un capo della polizia e predicatore, insieme al quale inizia a cantare musica country e gospel: basterebbe solamente la storia personale di Josh Harty per ascriverlo al nutrito elenco dei tanti "beautiful losers" che affollano la musica americana. Musicisti e cantori che dagli spazi più angusti e nascosti dell'America rurale provano a far sentire la propria voce, il più delle volte cadendo preda dell'oblio, illusi e spesso sbeffeggiati da un mercato discografico sempre meno magnanimo e sempre più legato alla logica del profitto. Il ragazzo in questione ha però classe e stoffa da vendere, che traspirano da ogni solco di questo suo ultimo ep Nowhere. Un concentrato di tutti gli ingredienti alla base della musica americana, nella più pura accezione del termine; una riuscita miscela tra folk e country, che richiama paesaggi rurali e vita agreste, in una sorta di quadro bucolico in musica. Musica acustica, per palati fini, un pugno di canzoni che cattura e conquista fin dal primo ascolto, per semplicità e bellezza. Merito senza dubbio della penna ispirata del nostro e di una voce dalla liricità strabiliante, il tutto su di un impianto strumentale nel quale a regnare è la chitarra acustica sapientemente pizzicata dallo stesso Harty.
 Trentatrè anni, dal North Dakota, figlio di un capo della polizia e predicatore, insieme al quale inizia a cantare musica country e gospel: basterebbe solamente la storia personale di Josh Harty per ascriverlo al nutrito elenco dei tanti "beautiful losers" che affollano la musica americana. Musicisti e cantori che dagli spazi più angusti e nascosti dell'America rurale provano a far sentire la propria voce, il più delle volte cadendo preda dell'oblio, illusi e spesso sbeffeggiati da un mercato discografico sempre meno magnanimo e sempre più legato alla logica del profitto. Il ragazzo in questione ha però classe e stoffa da vendere, che traspirano da ogni solco di questo suo ultimo ep Nowhere. Un concentrato di tutti gli ingredienti alla base della musica americana, nella più pura accezione del termine; una riuscita miscela tra folk e country, che richiama paesaggi rurali e vita agreste, in una sorta di quadro bucolico in musica. Musica acustica, per palati fini, un pugno di canzoni che cattura e conquista fin dal primo ascolto, per semplicità e bellezza. Merito senza dubbio della penna ispirata del nostro e di una voce dalla liricità strabiliante, il tutto su di un impianto strumentale nel quale a regnare è la chitarra acustica sapientemente pizzicata dallo stesso Harty.
Trentatrè anni, dal North Dakota, figlio di un capo della polizia e predicatore, insieme al quale inizia a cantare musica country e gospel: basterebbe solamente la storia personale di Josh Harty per ascriverlo al nutrito elenco dei tanti "beautiful losers" che affollano la musica americana. Musicisti e cantori che dagli spazi più angusti e nascosti dell'America rurale provano a far sentire la propria voce, il più delle volte cadendo preda dell'oblio, illusi e spesso sbeffeggiati da un mercato discografico sempre meno magnanimo e sempre più legato alla logica del profitto. Il ragazzo in questione ha però classe e stoffa da vendere, che traspirano da ogni solco di questo suo ultimo ep Nowhere. Un concentrato di tutti gli ingredienti alla base della musica americana, nella più pura accezione del termine; una riuscita miscela tra folk e country, che richiama paesaggi rurali e vita agreste, in una sorta di quadro bucolico in musica. Musica acustica, per palati fini, un pugno di canzoni che cattura e conquista fin dal primo ascolto, per semplicità e bellezza. Merito senza dubbio della penna ispirata del nostro e di una voce dalla liricità strabiliante, il tutto su di un impianto strumentale nel quale a regnare è la chitarra acustica sapientemente pizzicata dallo stesso Harty.
Già dall'opener Whiskey and morphine si intuisce la caratura del songwriting del chitarrista del North Dakota, un diamante forse ancora grezzo ma che lascia intravedere una lucente purezza. La voce e la chitarra acustica sono gli elementi distintivi di un suono parco, a volte minimale, con gli interventi degli strumenti acustici sapientemente dosati, in una perfomance sofferta e vissuta, per un opening track dalla grande suggestione. Nowhere ricorda invece le sonorità care a songwriter come James Taylor, una splendida folk ballad dal sapore agrodolce, dove alla suadente voce del nostro fa da perfetto contraltare una voce femminile di indubbio fascino. Sweet Solution continua sulla falsariga delle precedenti, ma ha un incedere più marcato, grazie anche agli interventi del violino e del mandolino, ben supportati da una sezione ritmica mai invadente, contrassegnata da un contrabbasso minimale e da una batteria spazzolata con maestria.
Struggente è Yesterday, dove il mandolino di Trevor Krieger e l'accordion di Chris Cunningham si rincorrono per tutta la durata del brano, colorando ed arricchendo ulteriormente la chitarra acustica di Harty. On my Mind vede ancora il violino di Krieger in primo piano, impegnato a intessere un'avvolgente melodia intorno a uno dei brani più affascinanti dell'intero album. Il nostro dimostra di essere, oltre che a un fine songwriter, anche un buon esecutore, con la bella rilettura di 6th Avenue del conterraneo Brooks West, nella quale ritroviamo quel lirismo musicale di cui parlavamo poc'anzi, che è alla base del suono del nostro. Chiusura in solitario affidata a 1952 Vincent Black Lightning, riuscito reprise di un brano di Richard Thompson, che mette in mostra una volta di più la bravura di Harty alla chitarra acustica. Un ep questo Nowhere, intenso e ammaliante, forse in minima parte condizionato dalla breve durata, ma che non mancherà di affascinare tutti gli appassionati della musica americana di stampo acustico.
Iscriviti a:
Post (Atom)



